“Tra le eccellenze del nostro Paese ve n’è una che stiamo esportando da anni: sono le ragazze e i ragazzi soprattutto del Sud, costretti ad abbandonare i loro territori per cercare nuove opportunità all’estero: occorre invertire questa tendenza, i giovani sono la spinta propulsiva senza la quale ogni tentativo di rinnovamento è vano”.
Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, nel suo discorso di fiducia alle Camera del 9 settembre 2019 fa riferimento proprio all’annoso problema dell’emigrazione che affonda le radici fin quasi dalla fondazione dello Stato italiano. Trattasi di un leit motiv che abbonda sulla bocca di quasi tutti gli esponenti politici; tuttavia, le soluzioni adottate negli ultimi anni sono state tutte abbastanza effimere e contingenti.
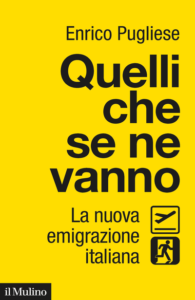 Per non affogare in un mare di parole ma per conoscere e capire la questione è molto utile leggere il libro del Professor Enrico Pugliese “Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana” edito da Il Mulino nel 2018. Oltre a passare in rassegna le principali ondate di emigrazione italiana verso l’estero nelle diverse epoche storiche, si afferma che il paese in cui viviamo è ancora terra di emigranti. Particolare attenzione, nel libro, è giustamente dedicata al Mezzogiorno. L’emigrazione dal Meridione, ci conferma l’autore, non è stata tuttavia sempre considerata un fenomeno così negativo: il flusso migratorio, infatti, ha permesso una sorta di riequilibrio della popolazione e, quindi, attraverso un alleggerimento demografico, il Sud è rimasto, nonostante tutto, una terra piena di giovani. Le rimesse degli emigranti hanno sostenuto per lunghi anni gli esercizi economici e le famiglie che, di sovente, rimanevano nei paesi di origine in attesa del ricongiungimento. L’emigrazione, soprattutto negli anni ’50 e ’60, si caratterizzava per essere prevalentemente di carattere rotatorio: dopo essersi spostati per lavoro soprattutto nei centri industriali, si riuscivano anche a mettere da parte risorse (con grandissimi sacrifici) per rientrare in Italia al più presto. Inoltre, con quelle stesse risorse si avviavano spesso attività nel paese di origine o si continuava a svolgere lo stesso lavoro esercitato all’estero, magari con altri lavoratori alle proprie dipendenze. Viceversa oggi, giovani e meno giovani abbandonano definitivamente le regioni meridionali e i ricongiungimenti familiari avvengono direttamente all’estero. Il libro parla, a tal proposito, del dramma delle regioni meridionali che si “ammalano” gravemente di senilizzazione. Lo studioso, richiamando una molteplicità di altri autori, parla, senza peraltro esagerare, di un vero e proprio tsunami demografico che ha investito il Sud con un saldo in perdita di ben 2 milioni di giovani negli ultimi anni. I dati citati nel libro confermano la trasformazione di quest’ultimo da luogo in cui abbondavano menti e braccia a regione spopolata e abbandonata al proprio destino, senza alcun investimento pubblico o privato. Merita un’ulteriore riflessione anche la scelta politica degli anni ’90 di chiudere e privatizzare IRI e quasi tutte le imprese di Stato e con esse rinunciare a ogni tipo di intervento di supporto e di rilancio. Da allora il Meridione, afflitto da deindustrializzazione e crisi, è stato lasciato completamente alla deriva; quando qualcuno se ne è interessato, si è proposto di reinserire, neanche troppo velatamente, gabbie salariali per comprimere ancor di più salari e diritti dei lavoratori, oppure da ultimo, sfruttando anche il progetto di autonomia differenziata, regionalizzando per esempio concorsi pubblici statali e graduatorie.
Per non affogare in un mare di parole ma per conoscere e capire la questione è molto utile leggere il libro del Professor Enrico Pugliese “Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana” edito da Il Mulino nel 2018. Oltre a passare in rassegna le principali ondate di emigrazione italiana verso l’estero nelle diverse epoche storiche, si afferma che il paese in cui viviamo è ancora terra di emigranti. Particolare attenzione, nel libro, è giustamente dedicata al Mezzogiorno. L’emigrazione dal Meridione, ci conferma l’autore, non è stata tuttavia sempre considerata un fenomeno così negativo: il flusso migratorio, infatti, ha permesso una sorta di riequilibrio della popolazione e, quindi, attraverso un alleggerimento demografico, il Sud è rimasto, nonostante tutto, una terra piena di giovani. Le rimesse degli emigranti hanno sostenuto per lunghi anni gli esercizi economici e le famiglie che, di sovente, rimanevano nei paesi di origine in attesa del ricongiungimento. L’emigrazione, soprattutto negli anni ’50 e ’60, si caratterizzava per essere prevalentemente di carattere rotatorio: dopo essersi spostati per lavoro soprattutto nei centri industriali, si riuscivano anche a mettere da parte risorse (con grandissimi sacrifici) per rientrare in Italia al più presto. Inoltre, con quelle stesse risorse si avviavano spesso attività nel paese di origine o si continuava a svolgere lo stesso lavoro esercitato all’estero, magari con altri lavoratori alle proprie dipendenze. Viceversa oggi, giovani e meno giovani abbandonano definitivamente le regioni meridionali e i ricongiungimenti familiari avvengono direttamente all’estero. Il libro parla, a tal proposito, del dramma delle regioni meridionali che si “ammalano” gravemente di senilizzazione. Lo studioso, richiamando una molteplicità di altri autori, parla, senza peraltro esagerare, di un vero e proprio tsunami demografico che ha investito il Sud con un saldo in perdita di ben 2 milioni di giovani negli ultimi anni. I dati citati nel libro confermano la trasformazione di quest’ultimo da luogo in cui abbondavano menti e braccia a regione spopolata e abbandonata al proprio destino, senza alcun investimento pubblico o privato. Merita un’ulteriore riflessione anche la scelta politica degli anni ’90 di chiudere e privatizzare IRI e quasi tutte le imprese di Stato e con esse rinunciare a ogni tipo di intervento di supporto e di rilancio. Da allora il Meridione, afflitto da deindustrializzazione e crisi, è stato lasciato completamente alla deriva; quando qualcuno se ne è interessato, si è proposto di reinserire, neanche troppo velatamente, gabbie salariali per comprimere ancor di più salari e diritti dei lavoratori, oppure da ultimo, sfruttando anche il progetto di autonomia differenziata, regionalizzando per esempio concorsi pubblici statali e graduatorie.
Nel libro, inoltre, si pone attenzione anche al fenomeno migratorio dei giovani meridionali che, per formarsi e studiare, si spostano presso le università del Nord. Qui conseguono un titolo e, spesso, si specializzano nelle materie tecnico-ingegneristiche e economiche-aziendali. Non si fermano, tuttavia, nelle regioni settentrionali: vi è una seconda emigrazione all’estero chiamata di rimbalzo, successiva e conseguente, diretta a poter svolgere un lavoro dignitoso e retribuito. Il Professor Pugliese, a conferma di ciò, ci porta dei dati sorprendenti, tra i quali balza all’occhio come sia, per esempio, la Lombardia la regione con più persone che vanno fuori dall’Italia per lavoro.
La cosiddetta nuova emigrazione italiana, successiva alla pesante crisi del 2008, si caratterizza per non essere esclusivamente una fuga di cervelli: i laureati espatriati negli ultimi anni sono circa il 30% per cento del totale degli emigranti. Il 70% delle persone che, per lavorare vanno all’estero, hanno un livello di istruzione inferiore alla laurea, a differenza dei luoghi comuni veicolati spesso dai media. Lo studioso fa riferimento anche ai numeri davvero ingenti di giovani laureati emigranti che si ritrovano in occupazioni di carattere manuale o comunque per le quali non è necessario, anzi a volte non è consigliabile, avere alcun titolo di studio. In questa medesima situazione, ovviamente, c’è un gran numero di giovani e meno giovani meridionali che lavorano al Nord.
Connesso ai crescenti flussi di emigranti italiani (i dati presenti nel libro sono inequivocabili e se ne fa rimando) l’autore fa notare anche il parallelismo tra Nord e Sud Italia che fa il paio con quello delle nazioni del Nord e Sud Europa. Trattasi di un dualismo propriamente economico, che è determinato tra l’altro anche dal modello mercantilista che è di origine tedesca. Nonostante la crisi (anche nella stessa Germania) sempre più evidente dovuta alla guerra dei dazi tra Usa e Cina, l’economia tedesca si fonda ancora sulle esportazioni. Il Sud Europa oltre a essere naturale bacino di sbocco delle merci, fornisce ancora tantissime figure lavorative, a basso e a alto valore aggiunto, che si trovano a vivere un mercato del lavoro assai segmentato e frastagliato. Quest’ultimo si fonda sempre di più su una richiesta di costante flessibilità e su una notevole biforcazione: da una parte vi sono occupazioni in settori avanzati ed ad alta innovazione, dall’altra c’è la grande maggioranza di lavori ove c’è lo sbocco della di un gran numero di emigranti italiani. Trattasi, ad esempio, del settore ristorativo e sanitario, dove si concentra la richiesta di figure lavorative. Tuttavia, il Professor Pugliese riporta anche le grandi difficoltà di potersi stabilire e inserire con contratti a zero ore o mini jobs tedeschi (una sorta di part time involontario a vita). Meritano un accenno anche i riferimenti e gli approfondimenti, presenti nel libro, al processo di regolazione a carattere liberista del mercato del lavoro europeo che si fonda su forme di precariato regolare e regolamentato. A tal proposito, l’opera di cui si consiglia la lettura, invita anche alla riflessione sul modello economico dominante, al ruolo svolto dagli stati nazionali e sul come è stata pensata e costruita l’UE reale, soprattutto in epoca di Brexit. Probabilmente, se si vuole arginare il definitivo spopolamento e desertificazione economica di intere regioni italiane e del Sud Europa è necessaria una profonda revisione e, forse, riscrittura dei trattati europei, cosa che, purtroppo, non pare essere presente nell’orizzonte politico attuale.
Immagine da www.wikipedia.org

A volte giurista, a volte demodé, sicuramente un lavoratore, certamente un partigiano.

