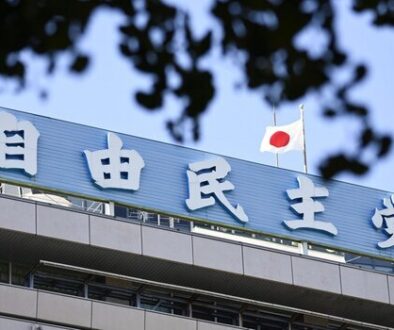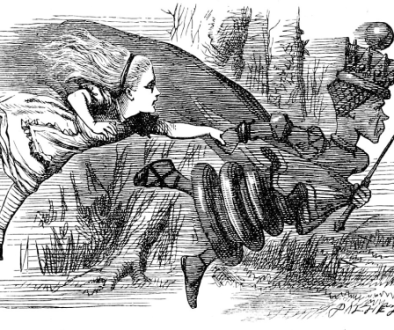Globalizzazione: nuova fase o post-globalizzazione?
Dopo una sola settimana i provvedimenti del tycoon stanno già facendo scalpore, in particolare l’abolizione del Tpp e la detassazione per le imprese che producono sul territorio con tassa di confine per chi produce all’estero stanno facendo preoccupare i mercati, più che rassicurarli, per una possibile guerra commerciale. Parallelamente, il discorso di Xi Jinping a Davos in difesa della globalizzazione ha sconvolto molti. Tuttavia, se gli Stati Uniti che stanno per entrare nel decimo anno di crisi (nessuna ripresa significativa è in atto) sembrano voler adottare politiche rivolte al protezionismo, la Cina invece è pronta a difendere l’ordine economico della globalizzazione anche ponendosi al posto del gigante in decadenza. A tutto ciò si aggiunge il riassestamento geopolitico con la Russia (vedi dichiarazioni di Lavrov sul riavvicinamento Usa-Russia nella lotta all’Isis). Nulla di stupefacente in un mondo non più unipolare, come sognavano gli Stati Uniti dopo il 1989. Più complesso è analizzare cosa ne sarà del mondo multipolare.

L’occidente appare sempre più impaurito in questi ultimi anni. Il fallimento di opzioni socialdemocratiche (sempre più sbiaditesi), l’ascesa imponente dell’estremismo sunnita, cambiamenti climatici e squilibri nella ricchezza che muovono milioni di uomini verso di noi, la crisi economica che dal 2008 morde: sono cose che hanno posto sul tavolo (spesso coi piedi) attori nuovi.
La risposta più cercata in molti casi sembra essere quella dei muri e delle destre nazionaliste e/o populiste (da Orban in Ungheria fino a Marine Le Pen, Grillo e Trump).
L’euro, i trattati di libero scambio e di libera circolazione sono malvisti da fasce sempre maggiori di popolazione. Personalmente non credo che il protezionismo sia la risposta anzi: dall’età moderna fino al passato più recente esso ha finito per portare con sé il tracollo di chi vi aveva aderito in maniera più stretta e ritardato innovazioni nei prodotti e maggiori costi per i consumatori. Anche il liberismo economico ha prodotto e produce devastazioni. Milioni di uomini che spremuti come limoni sono abbandonati da chi detiene i mezzi di produzione perché altri si fanno spremere meglio.
Qual è la soluzione? E quale il nocciolo della questione?
Esso risiede nel potere. È il potere, l’indirizzo verso il quale si muove, le classi che lo detengono a determinare la nascita di un Comecon o di una gabbia di austerità dalla quale si vuole fuggire nel nome di piccole patrie. È il potere a determinare se uno Stato possa o non possa essere parificato giuridicamente ad un’azienda.
In un mondo sempre più complesso, nel quale più nessuna economia è slegata dalle altre, le misure protezionistiche finiranno per far collassare anche chi le propugna lasciando in vita solo sacche di capitalismo parassitario e corporativo. La risposta, la nostra risposta, non può però nemmeno consistere nell’accodarsi a ex o neo progressisti scopertisi liberomercatisti.
È all’integrazione latino-americana ed in generale ai modelli win-win cui si deve guardare. Senza rincorrere le destre ma, proprio per questo, smascherando spremitori di uomini, padri di eserciti industriali di riserva e speculatori strutturalmente incapaci di produrre.

L’impressione è che si stia entrando in una fase di riassestamento dello scenario globale. L’ipotesi più plausibile letta finora, anche se viziata dall’astrazione dalla variabile impazzita “terrorismo internazionale” è quella della “globalizzazione complessa”(vedi qui). Il vero problema è capire quanto conflittuale sarà tale riassestamento e lungo quali faglie si scaricherà.
La globalizzazione, per come l’ho intesa, è inscritta nel processo di riproduzione capitalistico (vedi in particolare i Grundrisse) e non cesserà finché non si abolirà lo “stato delle cose presenti” a livello internazionale. Il protezionismo è solo un’arma che le potenze statali utilizzano nella lotta per la sopravvivenza nell’accumulazione del capitale, nulla di più nulla di meno. Questa nuova fase di riassestamento può essere concettualizzata e derubricata anche col termine “post-globalizzazione” a patto di non perdere il riferimento al processo di accumulazione che guida l’imperialismo. In particolare Homi Bhabha di fronte al referendum e agli attentati della scorsa estate ha dato una lettura della post-globalizzazione interessante basata sul concetto di “nazioni fallite” quali “categoria post-globale” fondamentale.
In un mondo in piena destrutturazione le identità si starebbero rafforzando sulla spinta dell’individualismo e del consumismo, ma senza ridursi ad un vero e proprio “scontro di civiltà”. Si sarebbero moltiplicati i ghetti, le divisioni, le diffidenze e la ricerca spasmodica di un’identità condivisa non farebbe che riflettere lo smarrimento della propria identità in un mondo pienamente mercificato. In questo senso il mondo continuerebbe a ruotare intorno alla principale frattura ordine mondiale/terrorismo internazionale. Da una parte un mondo in cui al welfare si sostituisce il warfare, dall’altra un mondo che percepisce come unica alternativa quella del perdente radicale (Cfr. Il perdente radicale, Hans Magnus Enzensberger, Einaudi, Torino, 2006) dove “l’importanza delle emozioni nell’intento politico”, come ricorda Bhabha più volte, gioca un ruolo centrale. Insomma, tra le tante promesse mancate della globalizzazione (e del capitalismo neoliberista) possiamo infine annoverare anche la libera circolazione dei capitali? Staremo a vedere. Il centro dell’impero ordina, i vassalli eseguono. Qualcuno pensa a sovvertire l’impero, qualcun altro a sostituirsi ad esso.

La globalizzazione. Abbiamo rinunciato a darne una lettura di sintesi che ci veda tutti concordi. Si parte solitamente, a sinistra, dalla critica alle scelte economiche, nel blocco occidentale, degli anni ’70. Si parla di finanziarizzazione e di progressiva dismissione dei diritti sociali conquistati in decenni di lotte, oltre che grazie alla lunga ombra del Muro di Berlino.
L’Unione Europea e l’illusione della “terza via” social-laburista avevano dato credito alla narrazione di un libero mercato globale capace di distribuire benefici per tutti, purché accompagnato dall’estensione legislativa in termini di possibilità dell’individuo. “Rendere possibile l’impossibile” sarebbe stato un ottimo slogan per la politica a cavallo del nuovo millennio, prima del crollo delle Torri Gemelle.
Obama era apparso come una possibile uscita liberal e progressista dallo “scontro di civiltà” fomentato da Bush jr. e dalla crisi scoppiata alla fine del primo decennio del nuovo millennio. Trump ha fatto saltare tutta la narrativa a cui fa riferimento un sistema di informazione già di per se “esclusivo”.
Facciamo l’esempio dei quotidiani, su cui mi è capitato di riflettere a seguito della delusione di un consumatore di un bar, poiché tra i miei giornali (scambiati per quelli del locale) non vi era una testata sportiva. Chi si informa ricercando notizie ed approfondimenti si colloca al di fuori del sentire comune e si immerge in un sistema di autoreferenzialità. Oggi probabilmente sta aumentando la distanza tra letture analitiche e processi reali. Utilizziamo termini fuorvianti. Il protezionismo non è più praticabile. La globalizzazione non è un processo reversibile. Sempre che a queste parole si dia il senso di un sistema che collega ed unisce tutta la sfera terrestre, dando la possibilità al capitale di svilupparsi al massimo delle sue possibilità.
Pensare che Trump, May, Putin o qualche altro “capo di stato” possa (o possano insieme) incrinare il sistema è degno di un tifoso che spera di vedere la propria squadra di terza categoria vincere il campionato della prima serie, almeno una volta nella vita. I trattati transnazionali garantivano un tipo di profitto, ai danni delle classi lavoratrici e di altri modi per “fare affari”. I meccanismi di sfruttamento possono cambiare, ma non è opportuno sostenerne alcuni, anziché altri.
Sarebbe interessante rileggere il sistema produttivo internazionale e capire il perché Trump non danneggi minimamente almeno un pezzo di borghesia occidentale. Si tratta però di un linguaggio vetusto, fuori moda, a cui troppo pochi paiono disposti ad appassionarsi.

È celebre la similitudine con cui Marx ed Engels descrivono la borghesia come uno stregone che non si mantiene in grado di controllare le potenze sotterranee che lui stesso ha evocato. I primi vagiti della presidenza Trump sembrano rispondere appieno a un disperato tentativo di riprendere il controllo. L’accostamento operato, da sostenitori o detrattori, fra Trump e il movimento no-global è fuori luogo, per il semplice motivo che l’etichetta no-global fu affibbiata dalla stampa a un movimento che si è sempre definito invece come “new global”, promotore cioè di una alter-globalizzazione.
Duecento anni fa gli artigiani inglesi ridotti dalla meccanizzazione a salariati depauperati iniziarono un tumultuoso sabotaggio degli impianti tessili, nella vana speranza di cancellare dalla storia l’avanzamento tecnologico che tanto aveva abbassato la domanda di forza-lavoro. Non solo quella rivolta fallì sanguinosamente, ma con il tempo dalla meccanizzazione industriale nacque il più forte movimento operaio nella storia dell’uomo, capace di ottenere in pochi decenni tutele sociali che per millenni erano state impensabili. A sua volta il progresso della tecnica consentì un miglioramento della qualità di vita anche per le classi popolari.
Anche oggi a spingere verso la globalizzazione è quel medesimo progresso che annulla spesso enormi distanze e si riverbera su tutta la popolazione (anche gli elettori antiglobalisti di Trump e Grillo usano WhatsApp e viaggiano per pochi euro con Ryanair).
Per questo pensare di potersi “difendere” dall’integrazione economica mondiale è illusorio tanto quanto fermare le varie rivoluzioni industriali che si susseguono da un quarto di millennio. La domanda non è se accettare o meno questo percorso della storia umana, ma come accettarlo, come governarlo. Il commercio equo e solidale mette in condizione di acquistare prodotti provenienti da ogni angolo del globo e come tale non è che l’altra faccia, la faccia corretta, del neoliberismo commerciale.
Per quanti hanno capito tutto questo, a partire dalla Cina di Xi, il trinceramento commerciale degli Stati Uniti non è altro che una grande opportunità: per rafforzare l’integrazione tra Ue e Cina e per espandere una rete internazionale che, nata su basi commerciali, può auspicabilmente estendersi a una politica estera di sicurezza collettiva. Il Messico, ad esempio, potrebbe ben diventare il più forte partner dei cinesi in Centroamerica e se la guerra commerciale dichiarata da Washington sta aumentando i consensi di Lopez Obrador, allora la presidenza Trump potrebbe anche fornire nuovo fiato al socialismo del XXI secolo in America Latina.

Si sono lette negli ultimi giorni molte analisi sulla fine della globalizzazione. Certo, due eventi strettamente connessi fra loro come la Brexit e l’elezione di Trump alla Casa Bianca, proprio in quei paesi in cui sono nate le politiche neoliberiste che hanno definito le regole e i rapporti economici degli ultimi 35 anni, non possono non avere un rilievo storico notevole. Ma pare troppo presto per trarne conclusioni affrettate.
Non vi è infatti nessuna forza politica di rilevanza mondiale che sembra intenzionata o abbia la forza di invertire quelli che sono i capisaldi dell’economia globalizzata a partire dalla finanziarizzazione, delocalizzazione e ristrutturazione tecnologica e organizzativa. Trump potrebbe introdurre dei correttivi a un sistema che si sta dimostrando fallimentare nel creare sviluppo e benessere e probabilmente una nuova strategia che implica la ricerca di nuovi e diversi partner commerciali, ma le sue dichiarazioni non fanno certo pensare a uno stravolgimento del sistema economico mondiale. Tutt’al più il neo-presidente americano, in questo quadro, potrebbe indirizzarsi su misure tiepidamente protezionistiche senza però cambiare nella sua struttura di fondo un sistema economico globale mastodontico e anonimo la cui portata va ben oltre i capricci estemporanei del singolo, anche se questi capricci sono quelli del Presidente dello Stato militarmente più forte al mondo. Con Trump e qualche suo potenziale imitatore la globalizzazione potrà anche subire delle variazioni rispetto a come l’abbiamo conosciuta negli ultimi decenni, ma resterà comunque un sistema orientato al profitto, allo sfruttamento e all’accumulazione di capitali imposto dall’alto.
Non sono e non possono essere queste le condizioni che permettono di portare a una trasformazione radicale del nostro mondo. Ad oggi non è morta la globalizzazione ma è in crisi la narrazione ottimistica di una società globale nella quale il superamento di ogni barriera spazio-temporale genererebbe maggiore felicità e benessere. Invece, la sempre maggiore consapevolezza che questo sistema produce solo miseria materiale ed esistenziale deve spingere alla ricerca di una alternativa radicale che nasca dai bisogni concreti delle classi meno abbienti. Qualche ricetta protezionistica dall’alto non cambia il quadro, è solo il sintomo di un malessere diffuso.

Ogni martedì, dieci mani, di cinque autori de Il Becco, che partono da punti di vista diversi, attorno al “tema della settimana”. Una sorta di editoriale collettivo, dove non si ricerca la sintesi o lo scontro, ma un confronto (possibilmente interessante e utile).
A volta sono otto, altre dodici (le mani dietro agli articoli): ci teniamo elastici.