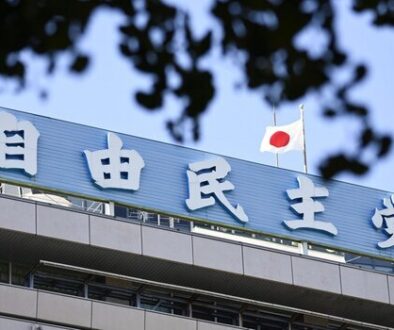Italia e legge sul fine vita: un futuro incerto
L’Italia, lo sappiamo, non brilla certo in tema di diritti civili. Il testamento biologico resta bloccato in parlamento e anche i diritti della persona non ricevono ancora il riconoscimento loro dovuto nel resto dei paesi occidentali. Nella bioetica e non solo la Chiesa continua a giocare un ruolo attivo intervenendo nella vita pubblica con un’autorità che, piaccia o meno, è ancora riconosciuta e rispettata dall’opinione pubblica a cui piace la trasgressione tipica del capitalismo libertario ma solo fino ad un certo punto. La questione posta dal caso di Dj Fabo riguarda l’eutanasia attiva e spinge il discorso dei diritti civili più in profondità: l’autodeterminazione si incontra e scontra con il progredire delle tecnologie in grado di mantenere in vita malati giunti al limite della sopportazione fisica della propria condizione. Parallelamente il dibattito sembra confinarsi sempre più nel puro esercizio delle libertà personali unite al progresso scientifico, dove si rivendica unicamente la possibilità di scelta di chi può permettersi la clinica privata per essere traghettato verso la “buona morte”.

È tutt’altro che semplice affrontare il tema del fine vita. Non è semplice in primo luogo perché in 2000 battute o poco più (il limite che mi sono dato per rispetto verso chi legge) non si può esaurire una riflessione che nemmeno in una biblioteca intera starebbe tutta. C’è sempre poi un po’ di pudore ad affrontare argomenti così enormi. Credo che quando si entra nella vita degli altri occorra farlo in punta di piedi, pulendosi prima le scarpe sul tappetino della decenza e del rispetto. Come si fa infatti a giudicare la sofferenza altrui? Il nostro metro è applicabile ad altri all’infuori di noi?
Un vecchio detto siciliano dice che i guai della pentola li sa il cucchiaio che gira.
Nessuno, ripeto nessuno, ha il diritto di creare una scala del dolore altrui. Ciò che per qualcuno è una pietruzza per altri può essere un macigno. I fatti di questi giorni però ci sbattono in faccia, per l’ennesima volta un qualcosa (che si chiami eutanasia, suicidio assistito, fine dell’accanimento terapeutico: tutte cose tra loro diverse e spesso volutamente confuse) che costringe ad una opinione.
Penso che debba essere diritto di ognuno, a prescindere dal suo stato psicofisico, disporre di sé. Non può essere un decreto, una tabella ministeriale, a stabilire quando sia giusto vivere o morire. Non esiste, ripeto, una scala di tollerabilità del dolore, della dignità. Esiste l’uomo e il suo diritto a dire basta: quando lo ritiene. Può un parlamento, un ministero, un ufficio stabilire una gerarchia o anche solo conoscere il livello di logorio interiore? Giudicare, certificare quale dolore è degno di essere terminato e quale debba invece proseguire: giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto.
Può un legislatore, un prete, un filosofo, un parente, giudicare quando un uomo può eseguire quel “basta”? Non può se muove una mano? Se le muove entrambe? Se è in piedi? Se il cuore batterà per tre giorni, tre mesi o trent’anni? E quando la questione non è medica ma sociale? Varo si suicidò per vergogna. Non aveva diritto a farlo? Chi non trova più motivi nel vivere, chi ritiene che in stato di incoscienza non ne avrebbe più (e dunque lo scrive prima), deve avere diritto a evitare la sofferenza. E’ diritto umano primario, naturale. Cosa vuol dire, infatti, essere vivi? Leggere, scrivere? O che batta il cuore? Ognuno ha la propria risposta.
La soluzione più semplice è probabilmente quella di importare una legge dall’estero, in linea di massima dall’Olanda. Ma né questo né altri parlamenti avranno il coraggio di assumersi questa responsabilità, anche coloro, probabilmente la maggioranza dei legislatori, che condividono questo principio di libertà. Non sono tra coloro che irridono quanti si schierano contro l’ipotesi di legiferare in merito. Non irrido loro come non irrido gli obiettori di coscienza (che comunque dovrebbero non operare nel pubblico). Non li irrido perché ho rispetto delle loro domande esistenziali. Temo però che le quelle legittime domande esistenziali impediscano agli individui di attuare un diritto che non coinvolge soggetti terzi. Un diritto che si esercita sull’unico bene realmente nostro: la vita.

L’idea dei maggiori filosofi contemporanei che hanno trattato il tema da Hans Jonas a Hugo Engelhardt mette al centro il timore che il progresso tecnico comporti una reificazione dell’uomo. Al fine di evitare questo Engelhardt definisce con attenzione una “comunità morale” fatta di persone in pieno possesso di autocoscienza, razionalità, senso morale minimo e libertà. In poche parole può intendersi una persona in senso sociale solo nel caso in cui si abbia a che fare con “individui ancora capaci di qualche interazione minimale” (H. Tristram Engelhardt jr., Manuale di bioetica, 1999 p. 172).
Come spiega Jonas il criterio generale che dovrebbe guidarci è ispirato al principio prudenziale, molto cautelativo nei confronti delle nuove metodiche scientifiche che rischierebbero per l’appunto di condurre l’uomo alla reificazione più perfetta. La possibilità di mantenere artificialmente in vita chi ritiene di non vivere più una vita degna è un caso da manuale dell’eterno conflitto tra uomo e macchina.
E anche l’opinione pubblica della cosiddetta società civile appare estremamente influenzata dall’individualismo per cui la sanità pubblica può essere privatizzata facendo mancare il sostegno economico, sanitario e sociale a larghissime fasce della popolazione malata e alle loro famiglie, mentre il diritto alla “buona morte” diventa una battaglia irrinunciabile. Conciliare questi due mondi, cioè quello dell’autodeterminazione e del progresso scientifico a giovamento dell’intera collettività per i comunisti che vogliono ragionare di etica è un dovere che però pone ostacoli non da poco nel capitalismo. Da una parte c’è l’autodeterminazione dell’essere umano già difficile in condizioni normali, dall’altra il progresso scientifico e una morale dominante che se non ostacolano del tutto la libera espressione tendono comunque a confinarla sempre più in codificazioni astratte estranee ai bisogni reali.

La superficialità è il peggior nemico dell’intelligenza umana. Spesso si accompagna alla mancanza di ironia ed autoironia. L’uomo è destinato a morire e dovrebbe vivere secondo le migliori condizioni possibili. In questa società questo appare impossibile. In tempi di decadenza politica appare curioso il sovrapporsi di alcuni intellettuali di (proclamata) formazione marxista e alcune tradizionali battaglie delle gerarchie ecclesiastiche cattoliche. La difesa della famiglia naturale e l’idea che la libertà della persona non appartenga solo al singolo.
Non viviamo isolati ed inevitabilmente ogni nostra scelta ha conseguenze su chi abbiamo intorno, all’interno del tessuto relazionale affettivo e non solo. “Cloro al clero” è una risposta di facile consolazione per chi rifiuta una lotta di egemonia all’interno del Paese, ma certo non è accettabile prestare il fianco a chi rifiuta di comprendere la sfida rappresentata dalla bioetica e dalle nuove scoperte scientifiche. Ci accaloriamo sulla vita delle persone, su singoli episodi, saltando di “moda” in “moda”.
L’alfabetizzazione dell’opinione pubblica deve essere una priorità della sinistra italiana: ognuno deve essere consapevole delle possibilità che il presente offre, dei rischi che si corrono ed essere accompagnato in percorsi in grado di esprimere la maggiore autodeterminazione possibile.
DJ Fabo e il caso Englaro non sono tra loro sovrapponibili. Ogni vita ha una sua storia e ci vorrebbe la decenza di non fare dell’esistenza di altri il campo per una battaglia di idee, solo perché manca la capacità di ascoltare il dibattito all’interno del Comitato Nazionale per la Bioetica o in altri luoghi della discussione.
Ci vuole coraggio per rendere pubblica la propria sofferenza e denunciare gli indecenti vuoti normativi, circondati da una ipocrisia ecclesiastica che confonde problematiche reali con la tutela di un consenso basato su presupposti reazionari.
Il modo migliore per rendere omaggio al coraggio e di averne altrettanto nell’affrontare le battaglie per la dignità sul giusto piano, magari accompagnandole a una lotta per una società più giusta, dove si è parte di una comunità (o di una classe) non tanto perché “figli di Dio”, ma perché esseri umani. La solidarietà e la dignità fuori dall’orizzonte teologico. La sinistra e i comunisti potrebbero riuscirci, magari evitando slogan come “cloro al clero” e ritirandosi dai dibattiti sbagliati in cui cerca di infilarci il sistema di informazione.

In merito al suicidio assistito, come già per l’interruzione volontaria di gravidanza, il legislatore dovrebbe prendere in considerazione tre principii irrinunciabili:
1. la tutela della dignità della vita umana
2. la libertà di scelta del paziente
3. la consapevolezza che si tratta di un rimedio storicamente transitorio, un male minore, prima che il progresso sociale o scientifico porti alla virtuale estinzione del fenomeno.
Mentre per l’esistenza è sufficiente essere biologicamente attivi, la vita propriamente detta non può fare a meno di proficue relazioni col mondo esterno. Perciò non sempre la tutela della dignità della vita coincide con la conservazione dell’esistenza (e in una gravidanza la tutela della donna deve avere la precedenza sulla tutela del feto).
Ad evitare che la vita dei malati terminali venga quindi definita a priori come assiologicamente inferiore provvede appunto il principio della libertà di scelta. Lo sterminio dei disabili attuato nella Germania nazista (e la sterilizzazione nella socialdemocratica Svezia) non prevedeva – evidentemente – alcun coinvolgimento della persona, considerata non un paziente bensì un rifiuto da rimuovere. Per cui suonano ridicole le accuse di neo-hitlerismo rivolte ai sostenitori del suicidio assistito.
D’altro canto non infondati sono i timori del diffondersi di una cultura che veda l’esito naturale della malattia nella morte e non nella vita. La possibilità di interrompere una gravidanza in modo legale è una garanzia sociale e personale, che protegge e donne e neonati da morti orribili. E tuttavia una società progredita, assicurando a tutti estesi diritti sociali, rimuove le cause del fenomeno aborto. La libertà di aborto non è quindi un punto di arrivo, bensì solo una tappa verso l’obiettivo della libertà dall’aborto.
Un ragionamento analogo vale sul suicidio assistito: se l’aspettativa di vita è passata dai 25 anni della preistoria agli oltre 80 di molti Paesi sviluppati si deve ritenere che il progresso scientifico produrrà occasioni di guarigione anche per malati oggi considerati terminali.
Tanto più che, nei Paesi con legislazione in materia, negli ultimi anni i casi di suicidio assistito sono rapidamente aumentati soprattutto a causa dell’incidenza tra i malati psichiatrici: persone che, per traumi subìti, hanno sviluppato uno stato depressivo così profondo da aver fatto valutare la malattia come “terminale”. Privare una persona della vita anche quando il disturbo è potenzialmente curabile, e in patologie in cui tentativi di suicidio sono causati dalla malattia stessa, sarebbe giustificato dalla sola insindacabile “volontà” del paziente.
È invece imperativo chiedersi quanto libera sia, o non sia, la volontà di una persona che sceglie la morte. Qualche anno fa venne fuori che la malattia per cui la sanità pubblica britannica registrava il maggior numero di pazienti era la depressione; oggi il Partito laburista ha un ministro-ombra per la Salute mentale.
Ponendoci il problema da una prospettiva di umanesimo risulta evidente che un suicidio assistito giustificato esclusivamente dal paziente sia una scelta di destra estrema, in direzione del darwinismo sociale; anche perché la vita non appartiene in toto al singolo: di essa beneficiano anche le sue conoscenze, i suoi cari e, in generale, tutta la società. Meno che mai sfugge che i casi di depressione, e di relativi suicidi assistiti, siano andati crescendo nel periodo della crisi economica.
Bisogna dunque distinguere tra i malati realmente terminali e altri malati, gravi ma non sempre terminali; e tenere presente che per entrambi i gruppi si deve tendere non alla libertà di suicidio ma alla libertà dal suicidio. Per la quale sono necessari il progresso scientifico e le rooseveltiane libertà dalla paura e libertà dal bisogno.

Ad oltre 10 anni dal caso Welby e a circa otto anni dalla morte di Eluana Englaro, ancora manca in Italia una legge sul fine vita. Le travagliate vicende legate alla figura di Dj Fabo hanno recentemente riacceso la discussione politica su temi quali eutanasia, suicidio assistito e testamento biologico, ma non è detto che si arrivi a qualcosa di concreto in tempi brevi. Nel frattempo però nel paese la percezione sembra essere decisamente cambiata: rispetto a 10 anni fa, c’è sicuramente più consapevolezza e informazione rispetto a questi delicati temi di bioetica, mentre le indagini eurispes mettono in luce la disposizione sempre più favorevole degli italiani rispetto a eutanasia, suicidio assistito e testamento biologico.
Le enormi difficoltà di tradurre questioni etico-filosofiche di questo spessore in leggi sta soprattutto nel fatto che non esiste alcun criterio oggettivo per stabile cosa si intenda per “qualità della vita” e quale sia la soglia oltre la quale vivere possa essere considerato insostenibile. Persino cosa si intenda per morte cambia da cultura e cultura e all’interno della stessa cultura nel corso del tempo. Per quanto la libertà illimitata su temi estremamente delicati raramente si traduce in benessere collettivo, occorre riconoscere che la decisione di disporre della propria vita appartiene solo e soltanto al singolo individuo, almeno ove in possesso delle sue facoltà di intendere e di volere. Allo Stato spetta il compito, tramite una regolamentazione ad hoc, di permettere di attuare la libertà individuale sulla propria morte e allo stesso tempo di ostacolare la possibilità che si presentino abusi o che si realizzino pratiche mercificatorie. In particolare, nel modello iper-utilitarista contemporaneo, in cui anche la sanità è valutata con criteri quasi unicamente di efficacia ed efficienza economica, occorre arginare quel paradigma che vede nelle persone gravemente malate ma vogliose di vivere un peso inutile per il welfare e per la società.
Una legge sul fine vita è insomma tanto urgente quanto necessaria sia per riconoscere un diritto a chi vuole cessare la propria esistenza sia anche per tutelare chi vuole vivere, proteggendolo da pratiche poco trasparenti e da possibili abusi dei trattamenti eutanasici.

Ogni martedì, dieci mani, di cinque autori de Il Becco, che partono da punti di vista diversi, attorno al “tema della settimana”. Una sorta di editoriale collettivo, dove non si ricerca la sintesi o lo scontro, ma un confronto (possibilmente interessante e utile).
A volta sono otto, altre dodici (le mani dietro agli articoli): ci teniamo elastici.