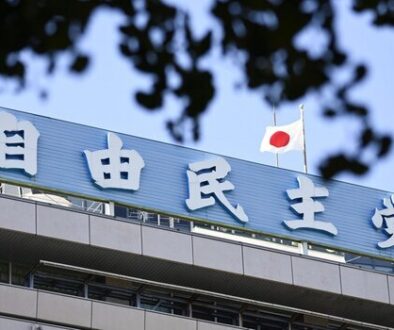Stati Uniti: catastrofe post Obama? (a dieci mani)
Il 10 gennaio, a quasi dieci anni dall’annuncio della candidatura alle primarie (10 febbraio 2007), Obama ha tenuto a Chicago il discorso di commiato alla nazione. Alla porta della Casa Bianca lo accompagnano 75 mesi di espansione occupazionale, un tasso di approvazione che sfiora il 60% e lo colloca al medesimo gradimento di fine mandato di altri popolari Presidenti (Eisenhower, Reagan e Clinton) e la convinzione – espressa poche settimane fa – che se la Costituzione gli avesse consentito un terzo mandato avrebbe potuto ottenerlo battendo Trump.
Questa convinzione è riecheggiata nel grido «Four more years» scandito a Chicago una folla ben più vasta di quella radunata in campagna elettorale da Hillary Clinton.
Ancora una volta il Presidente uscente ha tentato di salvaguardare il rispetto istituzionale ed evitato qualsiasi polemica verso il suo successore, cui ha assicurato «una transizione il più agevole possibile, proprio come il Presidente Bush fece per me», nonostante decine di parlamentari democratici stiano contestando la legittimità di Trump come Presidente.
Ma in effetti, oltre a difendere la propria eredità, Obama ha messo in guardia contro i quattro pericoli che a suo avviso minacciano la democrazia: l’iniquità sociale, il razzismo, il fanatismo politico e, soprattutto, la separazione tra cittadini e partecipazione politica.

Più che il discorso di Obama a Chicago, sovrabbondante di retorica (e la retorica degli altri dà sempre fastidio) mi ha colpito quello del vicepresidente Biden a Davos. Mi ha colpito per il tasso di russofobia istrerica, per la ricerca continua dello scontro e per la sua carica imperialistica. Mi ha poi colpito la frenesia postelettorale (dunque ormai a risultato ottenuto) dell’amministrazione Obama. Prescindendo dal merito (la commutazione della pena per Oscar Lopez Rivera, simbolo dell’indipendentismo portoricano è un fatto straordinariamente positivo) è del tutto inusuale che un Presidente in scadenza puntelli così tanto le proprie scelte e marchi così fortemente la distanza col proprio successore.
Sarà adesso da vedere cosa rimarrà in piedi degli otto anni di presidenza democratica. Scontato lo smatellamento dell’obamacare, cuore della propaganda di Trump ed utile a trovare parte (ancorché piccola perché la riforma di Obama non era nulla di rivoluzionario) dei soldi necessari ad abbattere la pressione fiscale sulle imprese. Più difficile sarà modificare l’accordo con l’Iran, forse il maggior successo della presidenza Obama, senza far indispettire una Russia con la quale Trump vuole costruire ponti. Diversa, e forse positiva, può essere la svolta sulla NATO, svolta annunciata con una chiarezza disarmante, a meno che nelle parole di Trump non si legga un invito agli europei ad aprire maggiormente il portafogli. Più che i discorsi sarà dunque utile tra quattro, tra otto, tra dieci anni, verificare quanto sarà sopravvissuto di un’amministrazione paternalista in politica interna e quantomai rapace in quella estera.


La presidenza americana appena conclusasi doveva essere quella del cambiamento e della svolta dopo gli anni terrificanti dei Bush e di Clinton. Doveva esserci un freno alla finanziarizzazione, la ripresa dell’occupazione e del reddito. Nulla di tutto ciò. Un grafico riassume bene ciò che è stata la presidenza Obama: continuità e mantenimento dello status quo. D’altra parte i democratici svolgono la tipica funzione socialdemocratica in difesa della classe borghese e devono nascondere la realtà e la crisi strutturale con “l’arma spirituale dell’addormentamento e dell’inganno delle masse” (L. Basso, Introduzione agli Scritti politici di R. Luxemburg, Editori Internazionali Riuniti, Roma, 2012, p. 56). Invece, la società capitalistica è ben lontana dal superare i propri squilibri che anzi, come ha rivelato il recente rapporto Oxfam, si stanno approfondendo.
Questi squilibri hanno condotto al cambio di linea politica negli Stati Uniti. La speranza in un cambiamento in senso progressista si è riversata nella svolta politica conservatrice di Trump. Se sarà una reale svolta o l’ennesimo mantenimento dello status quo lo scopriremo presto, infatti c’è da scommetterci che il prossimo presidente non tarderà a far capire le proprie intenzioni mentre Obama passerà alla storia come un presidente debole, capace solamente di eccitare gli entusiasmi di qualche sparuto nucleo di intellettuali (Cfr. A. Asor Rosa, Il grande silenzio. Intervista sugli intellettuali, Laterza, Roma-Bari, 2009) o poco più.

La realizzazione di un sogno. Questo era sembrato l’insediamento di Obama a molti elettori statunitense e a larga parte delle opinioni pubbliche occidentali. Una storia da Hollywood, di quelle che ci fanno sentire meglio. Un grande oratore, capace di trasmettere fiducia rispetto a quella parte buona che in fondo è dentro ognuno di noi. Trump appare come l’esatto opposto, incarnando i peggiori istinti dell’uomo, sempre nell’ottica liberale egemone nel nostro emisfero.
Il premio nobel della pace conferito al Presidente degli Stati Uniti, in un decennio di destabilizzazione del Medio Oriente, fa parte della narrazione con cui verrà ricordato Obama. Passeranno in secondo piano i dati reali relativi alla discriminazione razziale, all’aumento della disuguaglianza sociale, all’assenza di un ricercato equilibrio geopolitico, al disprezzo dell’amministrazione dimostrato nei confronti dell’Europa.
La maggioranza della Camera e del Senato era in mano democratica? No. Obama ha rappresentato una parentesi, necessaria per ridare alle stelle e strisce quella dignità offuscata dalle imbarazzanti azioni di Bush jr.
Oggi l’inconsistente sogno si è concluso. Torna un forte movimento di opposizione (in campo artistico, in termini di mobilitazioni, et cetera). Ma stavolta non c’è più una “sinistra pacifista new-global/no-global” a dare speranza. Obama mantiene in buona salute il consenso attorno alla sua figura, ma ha dimostrato a chiunque che non è altro che una narrazione a cui vuole credere il “buon cuore” occidentale, nonostante manchino riscontri reali in termini di successi progressisti sotto l’ambito sociale, economico e nel campo della politica internazionale.

In perfetta coerenza con la sua decennale elaborazione, nel discorso di commiato alla nazione Obama ha tracciato una linea rossa tra la storia costituzionale americana e tutti gli avanzamenti materiali e sociali del Paese. In una trama di richiami a suoi illustri predecessori (Washington, Jefferson, Lincoln, F.D. Roosevelt), il 44° Presidente ha tratteggiato una lettura di sinistra dell’eccezionalismo americano, visto non come una perfezione a priori (anzi, ha definito il razzismo «una minaccia antica quanto la nazione stessa») ma come la costante e coerente espansione dei principii illuministi: ad essa si devono la Rivoluzione, la conquista dell’Ovest, l’abolizione della schiavitù, il melting pot, il femminismo, le lotte operaie, la guerra antifascista, i movimenti per i diritti civili, la corsa allo spazio. Tale lettura non è affatto dissimile dall’elaborazione, ad esempio, del Partito comunista statunitense negli anni Trenta.
Il contrasto con il costituzionalismo di destra, che fossilizza la Carta nei suoi significati letterali del 1787 («la Costituzione di per sé è solo un pezzo di pergamena», ha invece ammonito Obama), si è accompagnato ad una velata polemica a distanza con Hillary Clinton: a proposito delle relazioni razziali ha osservato che «le leggi da sole non bastano; devono cambiare gli animi» (durante la campagna elettorale la Clinton fu tacciata di eccessivo cinismo per aver detto che non potendo cambiare l’animo dei razzisti bisogna invece investire sulle “armi” legislative e istituzionali). Pur riconoscendo che gli animi impiegano spesso generazioni per mutare, Obama ha offerto l’esempio pratico di Atticus Finch, l’avvocato de “Il buio oltre la siepe” – «mettersi nei panni degli altri e andarci un po’ a spasso» – per definire come esclusi tanto gli operai bianchi di mezza età quanto gli afroamericani e gli immigrati, e forgiare così una comune solidarietà.
Il Presidente uscente ha più volte sottolineato che tutte le riforme varate dalla sua amministrazione sono dovute non a lui ma al movimento che lo ha sostenuto, in quanto la partecipazione attiva della popolazione è il vero motore del regime democratico: in esso «la carica pubblica più importante è quella di cittadino» e la democrazia è messa in pericolo ogniqualvolta la si dia per scontata, perché i principii fondamentali della Dichiarazione d’Indipendenza – la naturale eguaglianza di tutti gli uomini – sono sì «autoevidenti, ma non auto-applicanti».
Molto più cupa è stata la visione sul resto del mondo. Tanto il terrorismo islamista quanto «autocrati stranieri ostili al libero mercato, alla democrazia e alla società civile» starebbero minacciando l’ordine atlantico post-1945, basato – a detta di Obama – su principii democratici condivisi oltre che su alleanze militari. In questa lettura gli Usa non hanno responsabilità per le stragi in Ucraina e in Siria; e mentre in Ucraina il Partito comunista è messo al bando e i nazisti abbattono le statue di Lenin l’etichetta di «intolleranza del dissenso» è appiccicata su Russia e Cina, «grandi Paesi che prevaricano i vicini più piccoli» (si è invece perso il conto degli interventi militari del Pentagono in America Latina e delle ingerenze nei Paesi Nato).
Pur avendo denunziato il razzismo e l’intolleranza in patria, Obama replica lo stesso copione di Reagan che nel 1987 insignì della Presidential Medal of Freedom il giudice che aveva condannato a morte i Rosenberg. Il contrasto tra l’ampia visione progressista interna e quella internazionale da guerra fredda (non una novità per i democratici, da Wilson a Truman a Johnson) si fa surreale quando, poco dopo aver denunciato le violazioni in altri Paesi di «diritti umani, diritti delle donne, diritti LGBT» (e quelli dei lavoratori?), indica come gravi minacce alla democrazia oggi presenti negli Stati Uniti le restrizioni al voto, l’influenza politica del grande capitale e l’iniqua distribuzione dei collegi elettorali.
Questa natura bifronte dell’ultimo discorso presidenziale di Obama riflette del resto l’analogo crinale che divide attualmente il Partito democratico: gli oppositori intransigenti di Trump sono fermamente antirussi, mentre i favorevoli alla riconciliazione con la Russia sono anche disposti al compromesso con Trump.

Le violente manifestazioni di Washington nel giorno dell’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump corroborano la percezione di un paese fortemente diviso ma testimoniano anche la scarsa lungimiranza politica delle forze della sinistra americana. Non solo si rischia di ampliare il consenso di cui il neo-presidente già gode, visto che le vetrine rotte e le macchine danneggiate quasi sempre rappresentano un boomerang politico, soprattutto in situazioni che oggettivamente (almeno per ora) non giustificano certi atteggiamenti, ma soprattutto si tende ad alimentare battaglie politiche contro qualcuno rischiando di perdere di vista contenuti e contesto più ampio (un po’ come è accaduto in Italia con Berlusconi). L’ossessione per Trump infatti rischia di distogliere l’attenzione dagli elementi strutturali che si concretizzano in una lotta di potere tutta interna alle élite economiche e politiche mondiali fra i fautori di una sempre maggiore integrazione economica mondiale da perseguire riducendo i vincoli al mercato a prescindere dai costi sociali e umani che ne possono conseguire e coloro che invece pensano che la soluzione migliore sia il ritorno a un capitalismo nazionalista e neo-protezionista. In questo gioco, per quanto possa fare paura, Trump è poco più di una pedina.
Nell’ambito di una sinistra attenta alle questioni di classe, sembra che il tentativo di proporre una credibile proposta alternativa a questo duopolio ideologico abbia grosse difficoltà a sbocciare e che quindi stia prendendo sempre più piede un atteggiamento del “meno peggio”, cioè una sostanziale alleanza in chiave anti-Trump col capitalismo liberal edulcorato e politically correct, che rischia di avere conseguenze disastrose nel medio e lungo periodo poiché offre alle forze economiche e politiche liberiste che ad oggi stanno sfruttando o destabilizzando buona parte del Sud del mondo e attuando una feroce stretta all’immigrazione, la possibilità di farsi vedere agli occhi dell’opinione pubblica come quelle che, al contrario dell’orco Trump, sono tolleranti, antirazziste, umanitarie e aperte, quando in realtà è vero l’esatto contrario. Si tratta dello stesso equivoco che rischia di glorificare Obama come paladino dei valori progressisti quando in realtà ciò che ha caratterizzato la sua presidenza è stata una politica estera aggressiva e irresponsabile, una redistribuzione verso l’alto della ricchezza che ha massacrato il ceto medio e fatto riesplodere la mai risolta questione razziale e la mancanza di ogni controllo sul sistema borsistico e finanziario nonostante gli esiti disastrosi della crisi del 2007. Che questo personaggio sia diventato il simbolo del movimento anti-Trump con tanto di manifestanti che inneggiano a un “terzo mandato” e ad altri slogan incostituzionali è il simbolo dei tempi bui che stiamo vivendo.

Ogni martedì, dieci mani, di cinque autori de Il Becco, che partono da punti di vista diversi, attorno al “tema della settimana”. Una sorta di editoriale collettivo, dove non si ricerca la sintesi o lo scontro, ma un confronto (possibilmente interessante e utile).
A volta sono otto, altre dodici (le mani dietro agli articoli): ci teniamo elastici.