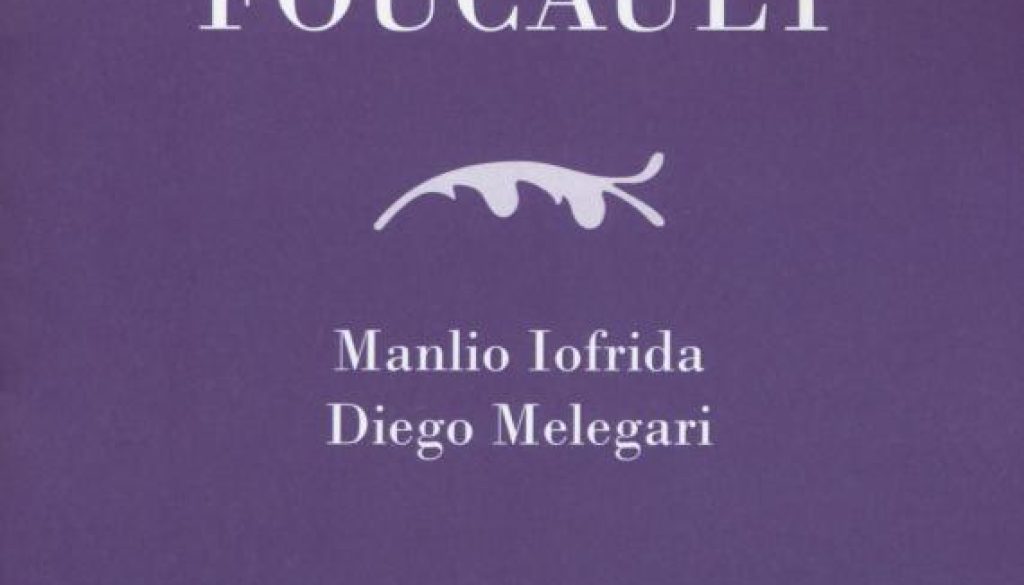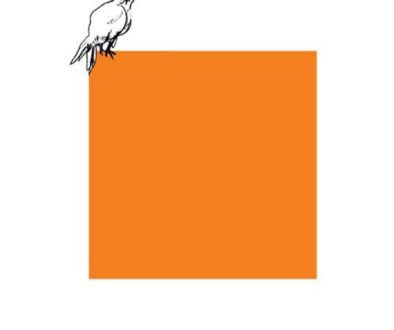Pubblicato per la prima volta l’8 dicembre 2017
È sempre difficile provare a parlare di un pensatore tanto produttivo e complesso quanto Michel Foucault. Ancor di più tentare di racchiudere il suo pensiero o i suoi “pensieri”, dato che, considerando le numerose fasi della dottrina foucaultiana, i critici parlano di un primo, di un secondo e se vogliamo, persino di un terzo Foucault. Ci hanno provato Manlio Iofrida, professore di storia della filosofia al Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna, e Diego Melegari, con il loro Foucault, libro edito da Carocci e la cui presentazione è stata organizzata lunedì 27 novembre presso il Gabinetto Vieusseux dal Gruppo Quinto Alto. Oltre agli autori del libro erano presenti Stefano Berni, cultore della materia in Filosofia del Diritto a Siena e che a lungo si è occupato della filosofia francese contemporanea e Stefano Righetti, altro esperto del pensiero foucaultiano e che fa parte del Coordinamento delle “Officine Filosofiche” e del Gruppo Quinto Alto, che hanno introdotto l’opera dei due filosofi e hanno posto alla loro attenzione questioni interessanti e stimolanti sollecitazioni.
Nell’introdurre i relatori, Ubaldo Fadini, professore di Filosofia Morale presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, afferma che il Foucault di Iofrida e Meregari non è la solita monografia sul pensiero di un autore né l’ennesima tesi di dottorato di un giovane studioso, ma è qualcosa di più. L’opera dei due autori, infatti, si pone il problema della spendibilità e della possibile attualizzazione del pensiero foucaultiano, del significato che questo può avere oggi mettendo però anche in luce le criticità e le problematiche presenti nella ricerca dell’autore francese.
Anche Stefano Righetti ribadisce che il valore di questo libro sta nell’essere tutt’altra cosa rispetto a quei libri che vogliono essere una sorta di mappa concettuale o di guida introduttiva al pensiero di un autore. Il libro di Iofrida e Melegari traccia un quadro del pensiero foucaultiano complessivo ma ponendosi l’idea di fare un bilancio di questo pensiero e riproponendo la lettura che di Foucault è stata intrapresa negli ultimi anni a Bologna, uno dei centri più interessanti e più floridi nell’ambito di studio del pensiero del filosofo francese. Il libro è una restituzione di questa lettura interpretativa sviluppatasi nei circoli intellettuali e accademici bolognesi e quindi il lavoro dei due autori è anche un lavoro di metodo. Metodo che si dà per oggetto insieme ai contenuti dell’opera.
A Bologna, infatti, prosegue Righetti, si è trattato di lavorare sul pensiero di Foucault in una prospettiva che tiene conto dell’orizzonte e del contesto storico-politico in cui si è sviluppato il pensiero dell’autore francese. Si tratta perciò di un taglio storico, teorico e critico sul pensiero degli autori della filosofia contemporanea a cui appunto si aggiunge anche una prospettiva di metodo. È un approccio che Righetti non disdegna di definire “storicismo italiano”, nonostante la denigrazione che quest’ultimo possa aver avuto negli ultimi tempi.
Infatti, anche laddove viene dato grande respiro ai punti di vista più prettamente politici non viene mai a mancare questo sguardo storico, teorico e critico. Nel libro emergono anche, prosegue Righetti, i forti riferimenti e le fonti nascoste del pensiero foucaultiano, non sempre facili da individuare proprio per una mancata esplicitazione da parte dell’autore francese.
A detta di Berni però, nonostante la complessità, e spesso la “flessibilità” e i cambiamenti costanti insiti all’interno della ricerca foucaultiana, è possibile rintracciare nel libro di Iofrida e Melegari una certa costante, che è quella della questione del linguaggio e soprattutto del rapporto tra il “linguaggio dionisiaco” del primo Foucault (quello, per capirci, di Storia della follia) e del linguaggio-istituzione, del linguaggio disciplinare, del linguaggio, per usare termini nietzschiani (Nietzsche, anche a parere degli autori, è una delle fonti principali di Foucault, soprattutto del primo Foucault), apollineo, contrapposto appunto a quello dell’irrazionale, letterario, dionisiaco.
Il percorso di Foucault, per quanto ricco di cambi di rotta, di inversioni di pensiero, è, secondo Righetti, tutto articolato all’interno del linguaggio proprio perché per l’appunto si intravede, nella sua ricerca, un costante confronto tra vita-potere-linguaggio. Si avverte, fin dall’inizio una tensione, una sorta di dualità continua tra linguaggio istituito, linguaggio-istituzione, linguaggio discorsivo/disciplinare/performativo e invece un linguaggio che ipostatizzato ai suoi estremi cerca di dar voce a ciò e a chi non ha e non può aver voce: il linguaggio del silenzio, il linguaggio dell’irrazionale, il non linguaggio del folle e della follia che trova appunto come suo immediato contrapposto il linguaggio della scienza, della razionalità cartesiana.
La sfida del (primo) Foucault, sebbene in questa spinta così estrema di dar voce e linguaggio al silenzio e al non linguaggio è proprio quella di inserire tale silenzio e tale non linguaggio all’interno del linguaggio stesso, in un paradosso apparentemente insanabile. Nel percorso iniziale di Foucault infatti vi è un tentativo di arrivare alla parola muta della follia, di ricondurre il linguaggio al silenzio, al non linguaggio, ma, come sopra accennato all’interno del linguaggio stesso, portandolo all’estremo dei suoi limiti fino a superare questi ultimi.
L’altro estremo è quello di portare il linguaggio alla verità che l’esistenza stessa dice e mostra, nell’ottica di un linguaggio che emana dalla vita, dall’esistenza. Acquisisce importanza, allora, in questa spinta estremistica del linguaggio portato al punto in cui esso stesso si “esaurisce” o tocca comunque la sua “impotenza”, diventando parola dionisiaca, l’elemento della letteratura, che si pone come un linguaggio esteriore, un qualcosa di oltre, di ulteriore e di esteriore, di differente, rispetto al linguaggio istituito, rispetto al sapere-potere. Tanti sono pertanto gli influssi letterari (e filosofici) da cui prende alito l’analisi foucaultiana, a cominciare da Blanchot e Bataille. La lotta però viene tutta giocata sempre all’interno della struttura linguistica e discorsiva, si sviluppa tutta all’interno del linguaggio, che rimane imprescindibile anche laddove si cerca di superare la sua struttura istituzionale, disciplinare e performativa, la sua struttura di linguaggio-potere, linguaggio-istituzione.
Se mi si può permettere un paragone forse pindarico e magari fuorviante (di cui mi assumo la libertà), è un linguaggio che mi parrebbe vicino all’espressione mellvilliana dello scrivano Bartleby che col suo “I would prefer not to” si inserisce in quella zona di indistinzione, in quel limbo che rende impossibile qualsiasi tipo di decisionalità, portando ai suoi estremi la razionalità del logocentrismo, della discorsività, e rendendo a sua volta anche indiscernibile, come ci ricorda Agamben, seguendo la definizione di matrice aristotelica di potenza (la dunamys infatti è anche potenza di non, potenza di non essere, potenza che in sé contiene la possibilità di non essere e, scusatemi il gioco di parole, è potenza e al contempo impotenza, e che solo realizzandosi nell’atto, decide di abbandonare la sua potenza di non essere, donandosi nell’atto come potenza di, facendosi dunque dono di se stessa), il suo confine tra potenza e impotenza, tra potenza di e potenza di non.
Anche in Foucault, a me pare, il linguaggio sembra, in questa fase, spingersi alla sua impotenza di non essere linguaggio, per lo meno non linguaggio rintracciabile in un logos, in un potere discorsivo, istituito, razionale. È linguaggio spinto fin oltre i suoi confini linguistici, che tocca il confine ultimo del non linguaggio, della parola muta, dionisiaca e irrazionale del reietto, del folle, il linguaggio muto della follia, non racchiudibile all’interno di alcun discorso logico e linguistico ma che pur sempre, per l’autore francese si sviluppa e si (non) articola all’interno del linguaggio, sebbene linguaggio estremizzato allo spasmo, al limite della sua tensione, laddove la parola cede il suo posto a ciò che non ha voce e, se una voce rimane, è quella dell’irrazionale, dell’“anti-logos”: Foucault cerca di rendere la follia “soggetto” del suo libro tentando di restituirle parola, nel tentativo appunto, pregevole e impossibile, di scrivere una storia della follia in se stessa. La difficoltà maggiore ovviamente sarà quella di fare una storia della follia come ci dice Foucault «prima di ogni cattura da parte del sapere».
Ciò che qui è in gioco quindi sta nell’evitare la trappola dell’aggressione razionalista e oggettivistica, sta nel mantenere il discorso senza alcun sostegno assoluto di una ragione o di un logos, nel rifiuto di articolarsi in una sintassi della ratio. Per questo si tratta per Foucault di legare la follia del silenzio, fare l’archeologia di questo silenzio, risalire all’origine di questo silenzio, della parola interdetta dei folli”[1].
La critica di Derrida sarà proprio quella relativa all’impossibilità di uscire da questa razionalità del logos, dalla ragione che comunque rimane il parametro anche per parlare di follia o di sragione: “Per Derrida la crisi classica si sviluppa a partire da e dentro la tradizione elementare di un logos che non ha contrari, ma porta in sé e dice ogni contraddizione determinata; esclude inoltre, […], che si possa fare storia del silenzio della follia respingendo in blocco la lingua della ragione e cioè la lingua dell’ordine perché non si può dar alla follia stessa (intesa non come un argomento, ma come soggetto parlante), se non ponendosi già dalla parte della ragione stessa perché la ragione non è un ordine di fatti, potremmo dire è inoltrepassabile”[2].

Alla fine degli anni ’60 (anche grazie all’esperienza del ’68) e all’inizio degli anni ’70 questa dimensione però sembra non bastare più a Foucault, che pare incentrato maggiormente sulla lotta politica, attiva. In questa fase l’autore francese sembra voler uscire dall’orizzonte stretto del linguaggio e attraverso il piano sociale e di lotta si discosta dal linguaggio letterario che in questo momento non costituisce più per lui un’alterità o una reale alternativa rispetto al sapere-potere, proprio perché rimane esso stesso a far parte di questa struttura disciplinare. Il linguaggio letterario, il linguaggio irrazional-dionisiaco non è più qualcosa di altro rispetto al sistema discorsivo-performativo, al sistema del linguaggio-potere, del linguaggio istituzione, non rappresenta più un contro-potere, non è più trasgressivo.
Foucault trova allora adesso un altro modo per “contrapporsi” a questo sapere-potere, rintracciandolo nella filosofia analitica poiché legge in essa l’unica possibilità di annidamento della critica. Deriva da ciò la necessità di utilizzare, contrariamente all’uso letterario e dionisiaco del linguaggio, come era stato nel primo tempi, un linguaggio più neutro, più freddo, più asettico che si trova ad accompagnare però ogni lotta politica e sociale. Viene delineata un’elaborazione di una “microfisica del potere” che si esercita ovunque e a ogni livello: “Ai suoi occhi, la lezione proveniente dagli eventi del ’68 aveva indicato la strada: i movimenti avevano rigettato materialmente l’ordine della società disciplinare affermando dal basso, e con radicalità globalmente diffusa, che «non si accettava più di essere governati in un certo modo». Per dirla con Gilles Deleuze, quelle lotte avevano rappresentato «la messa a nudo di tutti i rapporti di potere, ovunque essi si esercitassero, cioè dappertutto». In questo modo, esse avevano squadernato apertamente il “concreto” stesso del potere – sosteneva Foucault – fin nelle maglie più fini della sua rete. Recepirne le indicazioni significava allora elaborare una “microfisica del potere” in grado di superare l’ossessione teorica della sovranità e di mostrare come la concretezza dei poteri e dei saperi avesse prodotto, storicamente e materialmente, l’assoggettamento delle menti e dei corpi: il governo di tutti e di ciascuno”[3].
Per restare nell’ambito della questione linguistica, adesso non si tratta più quindi del linguaggio del dionisiaco, del linguaggio letterario, del linguaggio-vita (seguendo le orme di Balnchot, Bataille…). Anche l’opinione sulla scienza in questa fase cambia: la scienza non è più un mero dispositivo di potere, un dispositivo di verità, ma proprio perché procede a tentativi e spesso mette in questione se stessa, contiene in sé la possibilità di una critica e di un’autocritica, non risultando una struttura che si vuole semplicemente imporre e auto-imporre.
La critica principale in questa fase è invece spostata all’esterno della struttura linguistica, del discorso, perché diretta verso il potere della polis, il potere dello Stato e delle istituzioni; e si viene a creare una coincidenza tra soggetto-linguaggio e verità. Emblema di tale coincidenza è rappresentato per Foucault dai cinici greci, il cui esempio pratico di esistenza dice e mostra la verità: il soggetto nella sua pratica di vita, afferma/dice e soprattutto mostra la sua verità, in questa “parresia” in cui la vita coincide con ciò che essa stessa è in grado di dire (e mostrare), coincide con la sua verità realizzando quel passaggio che permette al linguaggio di sgorgare dalla vita stessa.
[Continua nei prossimi giorni]
Copertina edizioni Carocci

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.