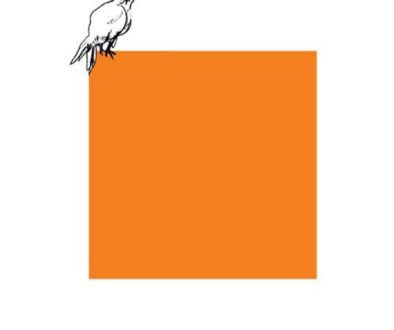In questi giorni, per credo ovvi motivi, sono stata portata a (ri)pensare alla fragilità dell’esistenza e in particolare alla fragilità, o vulnerabilità del corpo. Paradossalmente (ma se ci pensiamo non si tratta di un paradosso), proprio la caratteristica più straordinaria dell’esistenza, corporea ma anche ontologica, è la sua possibilità intrinseca all’apertura, al mescolamento, al con-tatto, al “contagio”, allo scambio ininterrotto e sempre rinnovantesi con altre esistenze e con altri corpi. Mescolarsi agli altri e mescolarsi nel mondo, schiudersi e aprirsi come soggetti e come corpi alle esperienze che si riversano in noi, è qualcosa di immenso, incontenibile.
L’apertura all’altro è apertura alle infinite possibilità che ogni incontro dona, sia a livello corporeo (carezze, con-tatti, abbracci, sguardi ecc.) che interiore e mentale. Il nostro esistere, il nostro essere, è, per dirla con Jean-Luc Nancy (che ritornerà anche più avanti) un con-esserci. Un essere-con. Un Mit-da sein.
Non è un caso che le nostre primissime esperienze siano tattili, comincino con il contatto. Contatto che è conoscenza del mondo, incontro con il mondo circostante. Con il corpo del mondo e con gli altri corpi.
Tutti i messaggi che provengono dall’ambiente esterno vengono interpretati ed elaborati fin dalla primissima infanzia attraverso la “sperimentazione del con-tatto, della sintonizzazione, dell’empatia, dell’intimità con l’altro nell’ambiente-mondo. Tutto questo organizza e struttura l’identità della persona e definisce il suo mondo proprio come senso di appartenenza ed esistenza. È grazie all’esperienza (Erlebnis) che la persona fa in questa costellazione di mondi possibili, che si organizza il suo essere-al-mondo. Il sé […] è ciò che rende possibile il con-tatto e la relazione intima con il mondo-della-vita (Lebenswelt) come esperienza vissuta”[1].
Noi abbiamo inizio con il corpo ed è per suo tramite che ci immettiamo nel mondo. Corpo che ci accompagna sempre e che ci fa essere anche per gli altri: è grazie alla mediazione del corpo che io posso percepirmi come persona ed esser percepita tale dagli altri, come entità, cioè, portatrice di un mondo non solo fisico (riconoscibile appunto dalla materialità del corpo), ma anche spirituale: “il corpo vissuto, quello che io sento, come io lo sento, è il fondamento della nostra soggettività e, dunque, anche della costruzione identitaria. La corporeità diviene, in altre parole, luogo della presenza […]. Non è una qualificazione del soggetto, ma è il soggetto stesso”[2].
La materia, la questione hyletica è dunque questione del nostro stesso essere, in quanto il soggetto corporeo, il corpo nella sua materialità può esser letto come “residuo della struttura conoscitiva del soggetto, quella struttura che racchiude a grappolo le nozioni di trascendentale, rappresentazionale, intenzionale, costitutivo, strutturale”[3].
Quindi il corpo è alla base della nostra esperienza e anche alla base della nostra struttura soggettiva e conoscitiva che ci permette di interagire con gli altri. Ma, come dicevamo, questa “esteriorità” rappresentata dal corpo e che gli permette di immergersi nel mondo e di costruire relazioni col mondo e con gli altri, di avere scambi con oggetti e con soggetti corporei è anche esposizione. Esposizione vulnerabile. Esposizione costante.
L’esposizione, la nudità indifesa dei corpi e il loro continuo mescolarsi, toccarsi, significa anche esposizione totale e inerme, abbandono ineluttabile al dolore del mondo, agli attacchi del mondo, alle sue possibili contaminazioni, ai suoi contagi (ma anche agli attacchi provenienti dal nostro stesso corpo, o dall’interno degli organi che lo compongono). Significa aprire le porte a un’esperienza che nel suo essere esperienza con-altri, nel nostro essere con, non può, nella sua nuda esposizione appunto, sfuggire alla sofferenza, alla malattia, alla ferita, ai colpi derivanti dall’affettività del nostro “essere-sempre-fuori” di noi, del nostro essere in comune e gettati nell’esteriorità dell’esistenza.
“Un corpo è estensione. Un corpo è esposizione. Non soltanto un corpo è esposto, piuttosto un corpo consiste nell’esporsi”[4]. L’esistenza è essa stessa pura esteriorità, esteriorità dei nostri corpi stranieri (estrusi più che intrusi) esposti e disposti ad accogliere dunque anche la violenza del mondo e degli altri; è un’esperienza in cui “ci si perde irrimediabilmente nella pura esteriorità dei corpi, nella loro inquietudine”[5].
Il soggetto è gettato, abbandonato all’esistenza L’essere è fin da subito esser-ci, nell’andare e venire dei corpi, nei loro con-tatti a fior di pelle.
L’esperienza della malattia rivela plasticamente o tangibilmente la fragilità, la provvisorietà del nostro esistere sempre in bilico, sempre in precario equilibrio tra la vita e la morte. Vi è come un lutto originario alla base di ogni esistenza, ossia il lutto per la propria finitezza, il proprio destino di morte. È un lutto spesso rimosso, addirittura reso tabù nell’era del post-umano, in cui appunto la tecnica, che agisce e interviene anche sui corpi, cerca in qualche modo di mascherare la morte, rimandandolo emendandola all’(impossibile quanto vano) infinito. È il lutto tacito ma sempre presente, anche solo a livello inconscio, per un’esistenza che nella sua strutturale esposizione è costantemente messa a rischio.
E la consapevolezza della propria vulnerabilità, della propria finitudine umana, diventa meno latente e più esplicitata, laddove vi è malattia, o contagio, o epidemia, laddove la vita stessa è messa sotto attacco, tanto da divenire una sorta di limbo che non è più né del tutto vita né ancora morte: “la malattia è l’esperienza che induce a prender dimora in quello che Rilke chiamava il doppio regno della coappartenenza di vita e morte”.[6].
L’irruzione dell’intruso, dell’inquilino indesiderato, del clandestino, provocata dalla malattia diviene così la figura più radicale di un’estraneità che non fa che iperbolizzare, in questo caso drammaticamente, quell’apertura all’altro e dell’altro “in noi” che ogni corpo non smette mai di ostentare. Ogni corpo si espone ad altri corpi e non c’è limite che possa frenare questa innata apertura dei corpi. Certo, ci si può, per lo meno periodicamente, isolare, chiudersi ai contatti e ai rapporti con gli altri, ma questi limiti che ci diamo non possono essere duraturi. Perché si ucciderebbe la nostra possibilità di arricchirci di esperienze, di creare relazioni con altri, si annullerebbe la nostra stessa possibilità di esperienza, di vita vissuta. Nessun uomo è un’isola, scriveva John Donne e non lo è costitutivamente; nonostante a volte si provi, ci si sforzi di chiudersi al mondo, il mondo entra comunque, l’io chiama l’altro e/o l’altro ci chiama, il corpo chiama contatti. Non per forza o non solo con altri corpi, ma semplicemente esistendo in un mondo fatto di oggetti, di aria, di vento, di luce, di erba. E certo, purtroppo anche di tanti residui tossici, inquinanti, che compromettono e attaccano costantemente il nostro fragile e sempre vulnerabile organismo.
Il corpo è aperto alla vita, tanto quanto lo è alla morte, è aperto alla costruzione (di relazioni, di esperienze, di scoperte, di bellezza, di esistenza), quanto alla auto e altrui distruzione (non solo del proprio o degli altrui corpi umani, ma anche di quelli animali e dell’ambiente stesso, del nostro stesso pianeta). Il corpo, il soggetto, crea e distrugge. E si costruisce e si distrugge. E non c’è risoluzione in questo. Siamo aperture e ferite. O, se vogliamo, aperture alla bellezza del mondo e degli incontri ma apertura anche alle ferite che da esso possono provenire o che, addirittura nascono già in seno al proprio stesso corpo. L’esterno non si può bloccare e quando l’esterno diventa parte dell’interno può farci bene oppure male. Come nel caso della malattia, della morte. La tecnica, accennavamo, tenta di respingere o allontanare, se non appunto rimuovere, questo tragico dato di fatto: la nostra infinita esposizione alla vita ma anche alla possibilità, prima o poi inesorabile, della sua fine.
La tecnica manipola i corpi, in alcuni casi li salva, come nel caso del già citato Jean Luc Nancy, che ha subito un trapianto di cuore. Esperienza su cui ha scritto il bellissimo L’intruso. In questo piccolo volume il filosofo parla dell’estraneità scavata e impiantata nel suo stesso corpo. Un’estraneità che gli permette di continuare a vivere, ma che lo rende, appunto, estraneo a sé stesso. Si trova ad avere un corpo estraneo nel suo stesso corpo: “L’ex-peau-sition è il luogo in cui non solo avviene il dissenso del corpo proprio di matrice fenomenologica, ma anche la dismisura della dimensione ontologica dell’essere-con. Il cuore trapiantato si fa spazio e, spaziando il corpo ricevente, lo s-partisce indefinitamente; è lì a con-tatto; ma, in questo suo con-tatto lo espropria, lo espone, lo esporta: il cuore nuovo è un fuori che porta fuori, che soppianta la tranquillità del Sé”[7].
L’eterogeneità del corpo implica dunque la techne del corpo, l’eco-tecnia dei corpi, ovvero la supplementarietà o la sopravvivenza tecnica del corpo, il suo destino di corpo “protesizzato”: “strani corpi stranieri […] corpi incisi, stampati, marcati, intagliati in microcosmi, in costellazioni: ignoranti del disastro. Strani corpi stranieri, sottratti al peso della loro nudità e tutti concentrati in se stessi, sotto la loro pelle satura di segni, […] corpi liberati e vivi, puri punti di una luce che si diffonde tutta in se stessa”[8].
Gli apparati tecnici, le appendici tecniche – di cui il cuore trapiantato di Nancy non è che un esempio – costituiscono un’estraneità radicale e irriducibile nel cuore stesso del “sé”, sono degli intrusi che rendono il corpo ancor più straniero a se stesso, ancor più disfatto, frammentizzato, ancora più esposto e disponibile, nonostante appunto gli conferiscano, in alcuni casi, un dono di vita che però in realtà “non allontana la morte, non dichiara la sua impossibilità, il suo non-ancora, ma incorpora il non dell’essere, l’impossibile nel possibile, lasciando agire la morte al cuore della vita, perché si installa come corpo estraneo proprio là dove la vita non riesce più a mantenersi da sola, là dove essa, lasciata a se stessa, cederebbe. Esso ricorda la non-tenuta della vita proprio nell’atto di supplire a questo cedimento, rivelandosi così, più che mai, pharmakon”[9].
Il corpo, al di là del caso specifico di quello di Nancy, si offre dunque anche all’accoglimento (o, di nuovo, all’esposizione) di una tecnica (trapianti, protesi, interventi chirurgici, sostituzioni ecc.) abolendo così fin da subito la dicotomia tra attività e passività e soprattutto tra proprio e improprio, così come tra la dimensione naturale della vita e quella tecnica, ormai così invasiva in ogni esperienza e ambito umani, sancendo un’estraneità e uno spossessamento che fin dall’inizio caratterizzano i nostri corpi e le nostre vite: “sono io stesso che divengo il mio intruso”[10], scrive Nancy.
Nel suo caso ovviamente, l’estraneità è duplice: l’estraneità della malattia e l’estraneità di un organo che viene sostituito da un trapianto: un carattere del tutto singolare della figura di Nancy è costituito proprio dalla sua ostensione come corpo malato, l’aver cioè condotto radicalmente il proprio pensiero della finitezza fin dentro a una personale esperienza della malattia, a una riflessione su quel “disordine nell’intimità” provocato dall’insediarsi in noi della malattia, non quella metafisica,“ma quella concreta e inaggirabile che ci assedia con il suo linguaggio dei sintomi, come un inquilino troppo socievole”[11].
Qui la questione dell’identità si problematizza iperbolicamente: io sono sempre io anche con un “corpo estraneo” in me? Sono sempre io, anche con un elemento tecnico che va a sostituire il mio cuore? Che ruolo gioca l’intruso in me? Si tratta di un nemico o una minaccia, o piuttosto è ciò che mi permette di continuare a vivere, pur rappresentando l’estraneità assoluta nel mio corpo, in ciò che chiamo “io”? Tra “io” ed “io” si insinua una dialettica sottile e impenetrabile, irrisolvibile; “La presenza dell’intruso (cuore trapiantato ma anche malattia) tocca la natura stessa dell’esistenza, il costitutivo stato di passività del soggetto, il luogo dell’affettività come origine di ogni processo di de-soggettivazione”[12], tanto da capovolgere il cogito ergo sum in un “ego patior, ego existo; l’affetto come patologia dell’esistenza, anima affettiva che trema, vibra, palpita.
La malattia, il cancro e poi la cura (attraverso il trapianto, la tecnica) divengono l’alterità cui il corpo è vulnerabilmente esposto o che anzi, nel caso specifico provengono dal corpo stesso, per minacciarlo, disintegrarlo addirittura, o sostituirne una parte, “macchinizzarlo”, alterarlo, disfacendolo e poi magari rifacendolo: “La questione non è che mi abbiano aperto, spalancato, per sostituirmi il cuore, ma che questa apertura non può essere richiusa. […] Io sono aperto chiuso. C’è in me un’apertura attraverso la quale passa un flusso incessante di estraneità. […] Lo sento distintamente ed è molto più forte di una sensazione: mai l’estraneità della mia propria identità, che pure mi è sempre stata presente, mi ha toccato così intensamente. «Io» è diventato chiaramente l’indice formale di una concatenazione inverificabile ed impalpabile. Fra me e me c’è sempre stato uno spazio-tempo: ma adesso c’è l’apertura di una incisione e l’irriconciliabile di un’immunità contrariata”[13].
L’esperienza dell’intruso, che non è solo quella di Nancy, ma potenzialmente quella di qualsiasi altro corpo, fa sì che la stessa esperienza corporea oscilli sempre tra il senso di una proprietà e quello di un’estraneità, tra il “mio” e il “non mio. E lo stesso vale per la malattia, o per l’epidemia, “corpi estranei” che si appropriano del mio corpo, che lo contagiano.
Il contagio è la figura per eccellenza che ha sempre distrutto o ammalato i corpi. E che ha assunto la forma del mostro assoluto, divenendo metafora di decadenza, di morte (si pensi alla Peste di Camus, ma anche alle figure degli zombie). Il contagio apre a scenari apocalittici e orrorifici, portando a galla tutti i tabù legati alla morte, alla precarietà dell’esistenza e alla sua insita fragilità, richiamando il senso di più disarmata e disperata impotenza.
Per questo, credo, si assiste a scene da “psicosi collettiva”. Ma non di psicosi o isteria si tratta, bensì della rappresentazione plastica, tangibile, disvelata della paura della morte richiamata dal contagio, più forte della paura della malattia in sé. Non si ha paura di morire, si ha paura di essere contagiati. Che il nostro corpo sia contagiato. E questo contiene anche la paura dell’altro, ancor di più visto come minaccia, come nemico da cui fuggire perché portatore di carica distruttiva. Negli scenari “epidemici” emergono tutte le pulsioni originarie, istintive e inconsce o sub-consce dell’essere umano: la paura, il terrore atavico della morte, la paura e la contrapposizione del sé all’altro e l’istinto all’ autoconservazione che, molte volte, dà sfogo a un egoismo assoluto, un individualismo sfrenato che, tra i denti, sembra sussurrare: “mors tua, vita mea”. La mia salvezza è più importante.
La razionalità e le competenze scientifiche, biomediche, non riescono a frenare gli impulsi primari di cui diventano preda molti esseri umani. Perché la paura della dissoluzione del corpo, la paura della contaminazione, la paura allo stato puro – che poi è sempre paura della morte – che nell’ordinario è come chiusa nel vaso di Pandora, nei momenti in cui si diffonde un virus o una epidemia, si sprigiona senza freni e, come una corrente ventosa, come un uragano, trascina tutto con sé, contaminando e contagiando. Paura chiama altra paura. Sempre. Questo è il vero e allarmante contagio. Si crea una eco di paura che perde persino, a volte, la ragione stessa della paura. O per lo meno perde il suo controllo razionale. Diventa passione (nel senso di Pathos, di qualcosa che si patisce) pura, senza contenimenti o misure proporzionali dettati dal raziocinio, dalla logica, dalla scienza.
E la paura non fa che ribadire il concetto da cui siamo partiti. Che siamo esposti. Che i nostri corpi, questi bordi, questi confini tra il dentro e il fuori, queste membrane così sottili che ci permettono di entrare nel mondo e di fare entrare il mondo dentro di noi, sono esseri disposti, disposti all’accoglimento dell’altro (inteso come mondo e altri) ed esposti di fronte a questo stesso accoglimento, e, in molti casi, sono corpi persino disponibili (quando un corpo diventa drammaticamente oggetto, oggetto a disposizione di altri corpi). Corpi esposti costantemente ad accogliere l’altro ma anche l’intruso, che va a denunciare e a sancire, appunto, l’inerme passività che ci costituisce.
Siamo vulnerabili e costitutivamente dipendenti dall’altro, inteso in tutti i sensi, non solo come l’altro umano. La vulnerabilità è condizione ontologica caratterizzante la nostra vita. Noi che crediamo di esser autosufficienti, autonomi, soggetti padroni, di noi stessi, degli altri, del nostro e spesso altri corpo, della terra, della natura, noi in realtà ci scopriamo nudi e fragili, prendiamo. scopriamo che alla base della nostra esistenza c’è la vulnerabilità, l’interdipendenza, l’esposizione, la fragilità, l’impotenza, la morte. E non abbiamo difese immunitarie contro questa condizione ontologica.
A partire dalla presa di consapevolezza della nostra costitutiva vulnerabilità e interdipendenza che ci consegna gli uni agli altri, si potrebbero pensare nuove forme di etica e di politica, in direzione di una comune solidarietà, in contrasto a forme di sovranismo, violenza, sfruttamento, guerra.
Capire di essere tutti ugualmente vulnerabili potrebbe farci riscoprire un perduto senso di cura, non solo per noi stessi, ma per gli altri e per tutto ciò che ci circonda. Se io riconosco la mia vulnerabilità la posso riconoscere anche in te e allora mi prendo cura di te, come cerco di prendermi cura di me stesso/a.
Il concetto di vulnerabilità sembra richiamare o comunque essere affine al discorso levinassiano sul volto dell’altro. Per Levinas è sempre l’incontro con l’altro a determinare il soggetto e l’altro si palesa come un volto che mi interpella e che sfugge a qualsiasi presa. Ogni volto è senza difese, inerme, esposto alla morte e all’uccisione. “Noi chiamiamo volto il modo in cui si presenta l’Altro. […] La vera natura del volto, il suo segreto sta altrove: nella domanda che mi rivolge, domanda che è al contempo una richiesta di aiuto e una minaccia” (Totalità e infinito). Ma nel volto, secondo Levinas, nell’“epifania” del volto dell’altro si racchiude una domanda di responsabilità. Il volto dell’altro mi interpella, mi chiede di essere accolto e io sono costantemente sottomesso a quella domanda di responsabilità.
Senza entrare nel pensiero levinassiano che è molto più complesso di così, quello su cui forse, anche in questi giorni di panico e di alcune misure da “stato di eccezione”, dovremmo riflettere, è il fatto che siamo tutti vulnerabili, potenzialmente. Poi ci sono vite più vulnerabili di altre, più precarie di altre, considerate più dispensabili di altre e meno intelligibili, secondo determinati regimi di verità, ma riconoscerci una costitutiva interdipendenza potrebbe/dovrebbe spingerci a trovare forme politiche ed etiche differenti dall’individualismo esasperato, dal mero profitto verso se stessi e la propria vita.
La presa di coscienza di una comune vulnerabilità può dar adito a diverse forme di legame sociale e ad azioni politiche, e sociali, che mirino a un bene collettivo, di tutti e tutte e non solo al benessere personale, anche in situazioni di emergenza, drammatiche, in cui, se da una parte c’è tutta una parte di umanità che si prende cura degli altri, dei loro corpi, dall’altra c’è invece si assiste a individualismo e un egoismo portato alle più iperboliche conseguenze. E questo accade comunque ogni giorno, giacché le asimmetrie e i rapporti di verticalità, di prevaricazione, di sfruttamento, distruzione, di violenza di/su altri corpi, altri soggetti, altre vite, sono dappertutto.
Anziché ostentare una forza e una sovranità sull’altro, dovremmo, direbbe Benjamin inclinarsi verso l’altro (di nuovo, inteso in ogni senso, umano e non), accoglierlo, esserne responsabili, prendersene cura. Perché ogni corpo è vulnerabile. E siamo tutti, ugualmente e inevitabilmente, esposti alla morte.
La morte nasce infatti nel seno stesso della vita, fin dal momento in cui apriamo per la prima volta gli occhi, perché quando nasciamo, siamo fin da subito esseri mortali. E questa sarà sempre la nostra primaria e sostanziale consistenza. Che forse è anche ciò che rende la vita così preziosa, in quanto perdibile, in quanto distruttibile, in quanto toccabile, dalla carezza, ma anche dal pugno. Dall’amore ma anche dalla malattia. Dalla bellezza ma anche dal decadimento. Dal contatto ma anche dal contagio. Perché i corpi sono pure esteriorità, sono il fuori che ci immette nel fuori del mondo, nel tessuto sociale e materiale in cui il contatto è, ad eccezione di casi limite, inevitabile.
“Il corpo è il limite, è l’escritto. È l’essere-esposto dell’essere […] il corpo è l’essere dell’esistenza, il luogo del suo accadere, l’apertura, la spaziatura, l’articolazione, l’effrazione, l’iscrizione del senso; se l’esistenza appare come un’esposizione corporea, allora il pensiero avrà come oggetto il corpo […] a questo pensiero inscritto nella corporeità esposta al mondo corrisponde la nudità dell’esistenza priva di ancoraggi metafisici, orfana di fondazione e di trascendenza, costantemente disponibile nella sua precaria e vulnerabile ostensione, sensuale expeausition”[14].
Malattia, dolore, morte, danno quindi vita a un pensiero tragico della finitezza e della vulnerabilità, a una consapevolezza drammatica e forse quasi insostenibile, ma paradossalmente, proprio perché questo pensiero della finitezza è anche un sapere dell’esteriorità e dell’apertura, l’esposizione, che ci rende vulnerabili e rende vulnerabili i nostri corpi è anche apertura all’altro, è riconoscimento dell’altro nella sua stessa esposizione e dipendenza. Nel suo spossessamento. È riconoscimento di essere, per riutilizzare il già abbastanza scomodato Nancy un ego-cum, espressione coniata dal filosofo per rovesciare, non solo provocatoriamente ma anche concettualmente, il vecchio ego-sum cartesiano. Il nostro essere è essere con altri. Siamo corpi in mezzo ad altri corpi, immersi nel corpo mondo e ognuno di questi corpi è esposto, vulnerabile, frangibile, tangibile, toccabile, frantumabile. Occorre perciò essere responsabili. Del nostro e dell’altrui corpo, perché come il mio può spezzarsi può spezzarsi il corpo dell’altro e io devo, sono tenuto a prendermi cura di entrambi. Come del corpo mondo.
Proprio in quanto prelude a un’ontologia del sensibile rivolta a “questo impalpabile reticolato di contiguità, di contatti tangenziali che è il mondo”[15], il pensiero della finitezza e della fragilità può diventare allo stesso tempo un pensiero della libertà e della responsabilità. I nostri corpi sono liberi e vulnerabili nella loro disarmante e disarmata nuda esposizione: “il tratto saliente dell’esistenza è […] l’essere al mondo di un soggetto che è infinita esposizione, nuda ostensione, vulnerabile esteriorità. Questo pensiero corporante è il risvolto, la piega, se non il sinonimo, del pensiero dell’esistenza, della sua invalicabile finitezza, quale scaturisce dall’abbandono dell’essere”[16].
Siamo esseri singolari e finiti, immersi nel con-essere, gettati fuori con il fuori che sono i nostri corpi: “ciò che si condivide è la singolarità della comparizione, di una venuta al mondo che accade nell’immanenza assoluta […], in una consegna priva di affidamento: «noi non possiamo comparire senza essere affetti l’uno dall’altro», l’affetto è il luogo del nostro essere in-comune, il suo clinamen che lo espone ad altri, la sporgenza sul bordo della singolarità, la sua dissoluzione come soggetto, l’accadere della sue estasi”[17]. Se la nostra è una condizione di esistenza condivisa, non possiamo sfuggire all’affetto, né all’effetto che hanno gli altri corpi sul nostro. Si possono porre limiti, ma non per sempre.
L’esposizione è una lama a doppio taglio, ma se da una parte può ferirci e perfino frantumarci, dall’altra può indurci a costruire forme di relazionalità e forme di azione sociale e politica in un’ottica più vicina a quella della cura e non della sopraffazione e dell’egoismo. Spostare l’accento dal contagio alla vulnerabilità dei corpi e dei soggetti può forse portarci a pensarci come esseri “inter-corporei” e intersoggettivi, interdipendenti gli uni dagli altri.
-
B. Fabbroni, La relazione con l’Altro-da-sé passa sempre per il corpo in B. Fabbroni, Il corpo racconta di colui che lo abita, Ed. Universitarie romane, Roma 2010, p.202. ↑
-
D. Erbuto, Riflessioni sull’esperienza della corporeità tra Leib e Korper, in CorpoNarrante (www.corponarrante.it). ↑
-
R. Lanfredini, Qualia e sensazioni: Merelau-Ponty e la nozione di esperienza, in Divenire Merleau-Ponty. Filosofia di un soggetto incarnato, Guerini e Associati, Milano 2011, p. 79. ↑
-
J.L. Nancy, Indizi sul corpo, p. 67. ↑
-
M. Vozza, A fior di pelle. Jean Luc Nancy e la filosofia del corpo, in J. L. Nancy, Indizi sul corpo, a cura di M. Vozza, Ananke, Torino 2009, p. 24. ↑
-
Ivi, pp. 24-25. ↑
-
D. Calabrò, Ex-peau-sition. Dal corpo alla dismisura dell’essere-con, in Pensare con Jean-Luc Nancy, op. cit, p. 45. ↑
-
J. Nancy, Corpus,Cronopio, Napoli 2000, pp. 10-11. ↑
-
R. Caldarone, Eros e techne. “Nella mano che trattiene/Una mano assente”, in Pensare con Jean-Luc Nancy, op. cit., p. 54. ↑
-
J. L. Nancy, L’intruso, trad. it. di V. Piazza, Cronopio, Napoli 2000, p. 28. ↑
-
D. Calabrò, op. cit. ↑
-
Ibidem. ↑
-
J. L. Nancy, L’intruso, op. cit, pp. 28-29. ↑
-
M. Vozza, op. cit., p. 7. ↑
-
Ibidem. ↑
-
Ivi, p. 11. ↑
-
Ivi, p. 16. ↑

Nata a Firenze nel 1988, sono una studentessa iscritta alla magistrale del corso di studi in scienze filosofiche. Mi sono sempre interessata ai temi della politica, ma inizialmente da semplice “spettatrice” (se escludiamo manifestazioni o partecipazioni a social forum), ma da quest’anno ho deciso, entrando a far parte dei GC, di dare un apporto più concreto a idee e battaglie che ritengo urgenti e importanti.