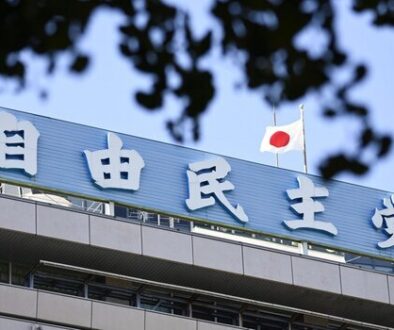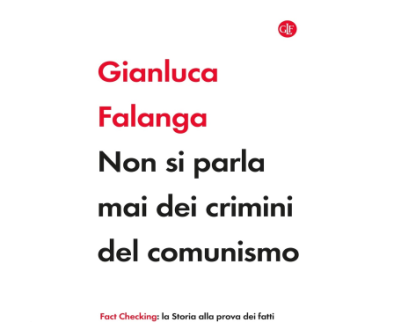Fin dal 14 marzo del 1883, data della morte fisica di Karl Marx (o di lì a poco) si aprirà un ampio dibattito sul superamento o revisione delle idee e delle tesi del filosofo di Treviri (che pur tuttavia non terminano, restano per lo più aperte). Questa riflessione non si è certo (mai) conclusa, continua fino ai nostri giorni. Donald Sassoon, celebre e prestigioso storico inglese, in un’intervista su “La Repubblica” dell’11 agosto del 2020, oltre a preannunciare l’uscita del suo nuovo saggio (The Anxious Triumph: a Global History of Capitalism), procede, incalzato dalle domande tranchant della giornalista, a demolire Marx perché non più adeguato a comprendere i tempi in cui viviamo. Avrà proprio ragione? Il Dieci mani di questa settimana prova a approfondire la questione avanzata da Sassoon e degli ulteriori interventi che ne sono stati originati.
Leonardo Croatto
E’ stupefacente l’interesse suscitato dall’intervista di Simonetta Fiori a Donald Sassoon, uscita su una Repubblica oramai definitivamente collocatasi nel campo liberal-conservatore. Nonostante lo spessore culturale dell’intervistato, le opinioni esposte dallo storico sono tutte pittosto generiche e poco interessanti; leggendo l’intervista si ha una sensazione di sfasamento tra domande e risposte da cui si riceve l’impressione che la Fiori voglia andare in una direzione che l’intervistato non è particolarmente interessato ad approfondire.
La strana asincronicità nel dialogo viene acuita dal lavoro del terzo non presente: il titolista, che, per soddisfare i bisogno di un giornale che oramai parla ad un pubblico manifestamente collocato a destra, attribuisce a Sassoon una dichiarazione virgolettata di cui non c’è esatto riscontro nell’intervista e che non si capisce da dove sia stata tirata fuori.
Lo storico accenna una critica a Marx teorizzando una supposta fine dello scontro tra classi, sostituito da un più moderno elemento di crisi legato alla sostenibilità ambientale. Che le due cose siano mutualmente esclusive e che la seconda abbia sostituito la prima meriterebbe una dimostrazione: le recenti dichiarazioni del presidente di Confindustra manifestano plasticamente come la lotta di classe sia viva e vegeta (la vera critica alla sinistra è che la lotta di classe è oggi un fenomento a senso unico in cui i padroni ménano e i proletari le prendono, senza alcuna reazione!), mentre l’attenzione non proprio recentissima dei marxisti agli eccessi di produzione e consumo che caratterizzano il capitalismo rendono evidente come il tema della sostenibilità ambientale sia già da molto tempo ben inquadrato nelle analisi della sinistra anticapitalista.
Una discussione sulla fallibilità della modellizzazione di certi fenomeni sociali prodotta da Marx è senza dubbio legittima e interessante; mettere alla prova la falsificabilità, in senso popperiano, dell’analisi marxista ne rafforzerebbe la validità, ma per una prova deduttiva dell’efficacia delle teorie di Marx serve molto più di una intervista che ha i toni e i contenuti di una chiacchierata da Bar Sport anticipata da un titolo sensazionalistico modellato con precisione sul ritratto del lettore medio di Repubblica.
Piergiorgio Desantis
Eterogenesi dei fini. Questioni male poste e, forse, non accuratamente risposte stanno smuovendo il dibattito culturale e politico europeo già da tempo asfittico (solo per utilizzare un eufemismo). Le risposte di uno storico di razza come Sassoon appaiono un po’ troppo facili o, meglio, semplificative. Si rimane un po’ delusi per questa contrapposizione, manco fosse un derby calcistico, tra il conflitto capitale/lavoro (made in Marx) e la questione ambientale. Già il filosofo di Treviri, infatti, individua in nuce alcuni elementi di contraddizione tra ambiente e sviluppo, ma, in ogni caso, “cercando d’afferrare con destrezza solo quanto si trova sulla strada” (per parafrasare lo stesso Marx) resta ancora pienamente centrale il lavoro nel mondo e il suo sfruttamento connesso, vieppiù in epoche di restrizione della quantità e della qualità del lavoro stesso. Stupisce come l’avanzamento tecnologico, la sostituzione a volte assai evidente dell’intelligenza artificiale all’uomo stesso (solo per citare macrotemi) non siano questioni meritevoli di approfondimento e studio per lo storico inglese. Per chi scrive, invece, ambiente e lavoro sono strettamente legati tra di loro, trovando spesso allocazioni simili in entrambe le polarità: spesso il consumo, l’uso e l’abuso delle risorse terrestri in maniera criminale si abbinano a condizioni lavorative precarie o inesistenti (soprattutto per le mansioni a basso valore aggiunto). Ciò vale, ovviamente, a contrario. Inoltre, circa i consumi di massa, davvero insostenibili per questo pianeta, diffusi in Occidente a partire dal secondo dopoguerra, Sassoon immagina che tutto si riprodurrà, uguale uguale, in Oriente, nella fattispecie in Cina. La classe media cinese, in altre parole, distruggerà l’ambiente e la terra (“Ma può il mondo permettersi un miliardo e mezzo di cinesi con lo stesso standard di vita dei californiani?” per citare l’intervista stessa). Ragionamento, anche questo, che forse pecca un po’ di meccanicismo perché davvero mette tra parentesi alcune delle caratteristiche della società cinese che vengono da lontano e, probabilmente, andranno lontano (vedasi la forte cultura confuciana che è ancora viva e presente). Per non parlare poi dei sicuri mutamenti di tutti i consumi imposti a livello mondiale a seguito della pandemia. Sarebbe il caso di interrogarsi anche su ciò. Circa gli interventi pubblicati in seguito e in rapida successione di Bertinotti e Rossanda, forse, anch’essi peccano di un’eccessiva volontà di schieramento (a favore o contro). Il manicheismo, soprattutto in caso di dibattito teorico, andrebbe evitato anche perché merita maggiormente orientarsi verso l’analisi, l’approfondimento e il ragionamento. Merci in effetti molto rare in queste epoche difficili e tormentate.
Dmitrij Palagi
Ci sono momenti in cui la speranza è che la CIA, un Emirato Arabo o gli Skrull stiano dietro alle situazioni a cui tocca assistere.È il caso del dibattito su Marx e natura.Il punto di partenza è semplicemente forzato e male impostato. Probabilmente superficiale, per quanto occorra modestia quando si esprimono i giudizi.L’intervista a Sassoon su la Repubblica è male impostata. Non contiene alcuna reale affermazione di sostituzione del conflitto capitale-lavoro con quello capitale-ambiente.Stupisce quindi che Fausto Bertinotti, sullo stesso quotidiano, abbia deciso di replicare allo storico britannico per invitarlo a riflette su come Marx avesse ancora qualcosa da dire anche a movimento come i Fridays For Future.Lascia poi del tutto spiazzati quanto è nato, a seguire, su il manifesto, con Luciana Castellina che ha tirato fuori il contesto di decenni passati, quando il “verde” era visto con sospetto dai “rossi”.Marx ha ancora qualcosa da dire? Sì. Escludendo l’ipotesi che Marx parli al presente come spirito rievocato o come oracolo profetico… Ha contribuito a comprendere la natura del capitalismo e di alcuni meccanismi economici (contribuito), permettendo al movimento comunista di svilupparsi in modo importante (non fondandolo da solo, come se la storia fosse un videogioco dove le azioni del singolo determinano lo svolgersi della narrazione).Giorgio Nebbia è stato una importante voce del comunismo italiano… Molti contributi che ha lasciato scritti sono utili. Tra questi una rilettura ecologica del secolo XX, che affronta anche il nodo del marxismo (vedi qui). La sinistra del XXI secolo non può essere accusata di ignorare il tema ambientale. Semmai di non approfondirlo. Di assecondare le mode e di non avere letture in profondità.Sassoon presta il fianco a questo approccio di superficie, complice l’età o l’operazione voluta dall’intervistatrice. Stupisce che si sia creato questo caso.La realtà e l’urgenza delle sfide contemporanee non si possono permettere queste distrazioni, che rimuovono la storia stessa di un’importante elaborazione che non è mancata in Europa.
Jacopo Vannucchi
L’argomento forte di Sassoon secondo cui il criterio marxista della storia come storia di lotte di classe non ha più validità analitica consiste nel dichiarare che il sistema capitalista oggi è più legittimato di 150 anni fa perché, rispetto ad allora, ne beneficia una quota immensamente superiore della popolazione.Questo, naturalmente, non è vero.«l’80 per cento della collettività sta molto meglio di nonni e bisnonni. Quasi tutti possiamo avere un’automobile, comprare il cellulare o la tv».La grave falla concettuale di questa affermazione è che definisce il benessere come quantità di consumo e non pone il problema del rapporto fra quantità di consumo e sostenibilità (privata e collettiva) del consumo. Avendo quindi già introiettato il paradigma culturale capitalista! Se infatti è vero, ad esempio, che uno strumento come il telefono cellulare può aumentare l’indipendenza personale, è necessario chiedersi come quello strumento venga impiegato. Il dilagare dell’ossessione narcisistica di alcuni social network appare un caso da manuale di moderno panem et circenses (soprattutto circenses). Inoltre, Sassoon non affronta la questione di quanta parte di questi consumi siano costruiti sull’indebitamento, nonostante già nel 2007-08 abbiamo assistito a una crisi economica fatta detonare dall’esposizione degli enti di credito nei confronti di debitori insolventi.D’altro canto l’urgenza della pressione ecologica viene senza dubbio riconosciuta dallo studioso inglese. Perciò stupisce ancora di più l’idea che la questione della sostenibilità ambientale possa essere considerata slegata da, o addirittura alternativa a, quella delle contraddizioni di classe. Tanto l’aspetto economico quanto quello ambientale, infatti, non sono altro che un contrasto fra gli attuali rapporti di produzione (squilibratissimi) e le forze produttive che vengono danneggiate nel tenore di vita: sia come potere d’acquisto sia come salute (il salto di specie di virus come il SARS-CoV-2, i crescenti problemi di siccità).
Alessandro Zabban
Il tentativo di dipingere Marx come inattuale è un’operazione che ha preso piede con la caduta del Muro di Berlino, contestualmente a una riconfigurazione globalista dell’economia capitalista che andava sostenuta propagandisticamente col motto della fine delle ideologie, della fine della storia e del TINA (“There Is No Alternative”). Questo tentativo di gettare nell’oblio Marx era funzionale alla lotta di classe condotta dall’alto da parte delle classi dominanti contro quelle subalterne, in un programma preciso, al quale hanno partecipato entusiasticamente anche ampi settori della sinistra, di risolvere il conflitto capitale – lavoro a favore del primo.L’intenzione di Sassoon non è certo quella di farsi strumento della classe dominante, ma riproduce un atteggiamento comune nella sinistra di messa in disparte del pensiero di Marx sul tema centrale del lavoro e del conflitto di classe. Il capitalismo è, come suggerisce Sassoon, un sistema flessibile, in grado di reinventarsi ed adattarsi continuamente, ma per comprendere i suoi elementi strutturali, non si può prescindere dall’analisi marxiana che ha saputo cogliere le contraddizioni distruttive del capitalismo che sono più attuali che mai, come dimostra la degenerazione della globalizzazione capitalista.Sassoon, volente o nolente, finisce per riprodurre gli errori e le ambiguità della sinistra contemporanea che ha cercato di sostituire al rapporto fra classi sociali e all’analisi degli interessi di classe, la più ambigua e vaga distinzione fra alto e basso, appressi e oppressori. La confusione teorica che caratterizza forze politiche contemporanee di sinistra anche di successo come Podemos sta proprio in questo allontanamento da Marx. Stare dalla parte degli oppressi non è lo stesso che stare dalla parte delle classi popolari perché esistono periodi storici in cui le classi popolari detengono il potere politico e hanno la forza di schiacciare la borghesia. Stare dalla parte degli oppressi significa stare a prescindere con chi si oppone a qualsiasi potere in grado di esercitare un forza coercitiva, mentre leggere il conflitto da una prospettiva di classe permette una visione più ampia ed evita pericolose semplificazioni che potrebbero portare a simpatizzare con forze reazionarie all’interno di paesi a guida socialista. Se la distinzione è solo fra oppressi e oppressori, risulta coerente per una persona che si definisce di sinistra simpatizzare con i movimenti che hanno distrutto l’Unione Sovietica e più recentemente con l’eterogenea e spesso poco idilliaca galassia di forze che si è messa contro Maduro o Morales in America del Sud. In un certo senso è proprio quello che sta facendo una grossa fetta della sinistra che ha abiurato l’analisi marxista, che complica il problema e amplia l’analisi con altri fattori. Rinunciare all’analisi di classe per identificarsi in maniera acritica e decontestualizzata con gli oppressi indica che il problema non è affatto Marx ma al contrario che ultimamente viene letto troppo poco.
Immagine da www.pikist.com

Ogni martedì, dieci mani, di cinque autori de Il Becco, che partono da punti di vista diversi, attorno al “tema della settimana”. Una sorta di editoriale collettivo, dove non si ricerca la sintesi o lo scontro, ma un confronto (possibilmente interessante e utile).
A volta sono otto, altre dodici (le mani dietro agli articoli): ci teniamo elastici.