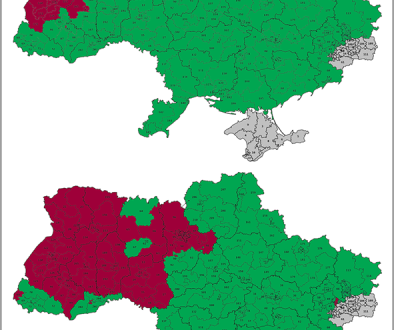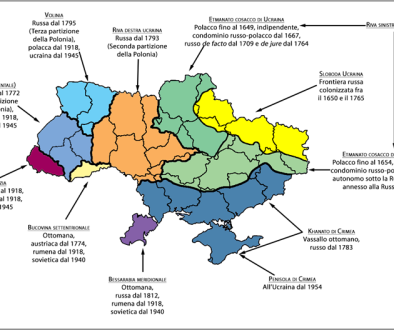“La democrazia, senza corpi intermedi, è come un corpo umano senza struttura ossea: si affloscia”, “La democrazia non si può fare senza i partiti”, “L’alternativa all’uomo forte sono i partiti forti”, “E’ stato teorizzato che bisognava fare un partito non più ideologico, leggero: teorie rispettabilissime, ma sbagliate. I partiti devono essere ideologici e avere una visione del mondo”, “I partiti, formando classe dirigente, consentivano a una parte del popolo di diventarlo. Quando metti questi meccanismi di autopromozione, come le primarie, la politica diventa l’attività a cui si indirizza un solo pezzo della società civile e viene occupata da una piccola borghesia rampante che ne fa un’occasione di promozione sociale”.
Dichiarazioni pesantemente in controtendenza con lo stato attuale della politica italiana, che fanno ancora più impressione perché a pronunciarle è Massimo D’Alema, dirigente di un partito ideologicamente connotato e fortemente strutturato trasformato in un contenitore ultraleggero secondo il modello americano. Modello che evidentemente, sia negli USA che in Italia, comincia a mostrare tutti i suoi limiti.
Leonardo Croatto
La trasformazione dei partiti da comunità viva e pensante di soggetti con un progetto comune a comitato elettorale di un notabilato di caratura etica e intellettuale inversamente proporzionale alle proprie ambizioni ha cause molteplici.
La rappresentazione della classe politica come soggetto in conflitto con gli interessi dei cittadini non è nuova alla storia delle democrazie liberali: è una narrazione che si ripresenta ciclicamente, in particolare nei momenti di crisi, e fa la fortuna di arruffapopoli spregiudicati che, facendo leva sulla disaffezione montante per la politica (quale azione di gruppi dirigenti disprezzati, magari anche per buoni motivi), propongono la compressione degli spazi democratici (fino al riassunto a uno solo) come purga per liberare lo spazio della rappresentanza da rappresentanti ritenuti poco rappresentativi. La storia ci insegna che il risultato di queste operazioni non è mai positivo per chi le ha desiderate.
Nella storia italiana Tangentopoli è stato sicuramente l’evento storico che ha causato il più grande capovolgimento di percezione nell’opinione pubblica del ruolo dei partiti di massa: da spazio di partecipazione aperto e diffuso a luogo chiuso e opaco in cui si saldano legami d’interesse particolare. La riorganizzazione successiva al crollo delle grandi formazioni politiche storiche – in chiave proprietaria a destra e plebiscitaristica a sinistra -, lungi dal ridare senso alla forma partito ha invece messo in moto meccanismi di personalizzazione che hanno interessato quelle stesse organizzazioni e, specularmente, l’assetto istituzionale.
La nascita della figura del “candidato premier”, i nomi propri di persona sui simboli elettorali, le campagne elettorali costruite sui singoli candidati anziché sui programmi, l’abitudine della stampa di identificare i partiti col segretario, la terribile legge elettorale dei comuni, lo svuotamento delle prerogative del parlamento in favore dell’esecutivo e via verticalizzando.
Se sono condivisibili le critiche di D’Alema (anche se si potrebbe ben dire che quelle dichiarazioni rappresentano un po’ la scoperta del buco alla conca), è proprio quella generazione di dirigenti politici che ha scelto di uscire dalla crisi dei partiti di massa imprimendo al nostro sistema di rappresentanza e all’architettura delle nostre istituzioni una svolta contraria alla maggior partecipazione.
Pur apprezzando quindi i pentimenti pubblici, è difficile immaginare che una riattivazione dei partiti come spazio di partecipazione e formazione possa avviarsi grazie al ruolo dei vecchi dirigenti responsabili del disastro e dai loro discepoli.
A noi che certe idee le abbiamo sempre sostenute resta l’amara soddisfazione del consueto: “eppure vi s’era avvertiti!”
Dmitrij Palagi
“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Così recita l’articolo 49 della Costituzione italiana. La partecipazione alla vita pubblica è un diritto e andrebbe immaginato come un elemento di prestigio, come è quando ci si mette al servizio della comunità per concorrere al miglioramento della società in cui si vive. Per farlo occorre una visione complessiva del reale e la capacità di avere chiaro in quale direzione muovere la propria quotidianità. Lottare per i propri diritti, per rispondere ai bisogni e al fine di riconoscere quello che si vive individualmente come questione comune è imprescindibile.
D’Alema raccoglie una formazione di un tempo passato e si dice convinto della migliore forma novecentesca, rispetto a quella del nuovo millennio.Se non fosse un protagonista della transizione al XXI secolo, almeno per quanto riguarda la socialdemocrazia occidentale, non sarebbero poi così rilevanti le sue frasi. Che sono affascinanti, ma sono tutto sommato legate a una persona. Mentre in politica le azioni si misurano o in risultati ottenuti o sulla base del consenso di cui godono…Non aggiungo quanto già scritto su una recente pubblicazione (vedi qui), ma si conferma rilevante l’interesse che viene dimostrata verso la Chiesa cattolica di Papa Francesco, da parte di settori importanti della tradizione comunista italiana.
Jacopo Vannucchi
Le frasi di D’Alema pongono tante questioni, forse troppo complesse per affrontarle qui. Mi limito a pochi flash. L’uso dell’aggettivo «ideologico» è problematico, perché, se si segue la definizione che Marx ed Engels danno nella «Ideologia tedesca», ideologia non è una qualsiasi visione della realtà, ma quelle visioni della realtà che programmaticamente mirano a distorcerne la percezione e a creare una falsa coscienza. Questa precisazione può essere oziosa, ma se si deve – come D’Alema crede e come io concordo – selezionare con rigore il gruppo dirigente non possiamo neppure permetterci equivoci semantici.Uso «gruppo dirigente» e non “classe dirigente” o, tantomeno, “classe politica”, perché neppure questi termini sono neutri. I politici non sono una classe, cioè una classe sociale. Il termine “classe politica” nasce nell’Ottocento in pensatori reazionari (Pareto, Mosca, Michels) impegnati nella denigrazione del movimento socialista e socialdemocratico di allora – “vedete, proprio i socialisti che parlano di classismo e che dividono la nazione costituiscono essi per primi una classe economica che ha interesse allo stipendio parlamentare!”.Fatte queste doverose premesse, va riconosciuta a D’Alema una preoccupazione di lunga data per le sorti dei partiti. Già nel 1993 scriveva sull’Unità che Tangentopoli rischiava di buttare via il bambino (la democrazia organizzata in partiti) conservando l’acqua sporca (la gestione opaca del potere). I trent’anni seguenti gli hanno indubbiamente dato ragione.Così come ha ragione nell’osservare che la politica ha perso il ruolo di rappresentanza di interessi generali per assuefarsi a clientele o addirittura ad autopromozioni. Ma questo problema, così come quello del declino nelle competenze dei governanti, temo che sia collegato ad un più generale problema di declino industriale e socio-economico dell’Italia. In altri termini: se non portiamo più gli operai in Parlamento è perché di operai in Italia ce ne sono sempre meno! Se i Ciampi hanno lasciato il posto ai Conte, è perché l’intero sistema economico italiano è cambiato, in linea con la deindustrializzazione del Paese e, voglio sottolineare, con la mancata integrazione armoniosa del mercato interno comunitario.Da toscano mi ha colpito molto una frase resa dal candidato di centrosinistra alla Presidenza della Regione, Eugenio Giani, che parlando dell’arretramento di consensi della sinistra nella sua terra ha detto a la Repubblica: «Si è anche allentato un modello di corpi intermedi, dai partiti all’associazionismo: un tessuto che passava attraverso le case del popolo». D’altro canto la cura dimagrante imposta al sistema politico non ha fatto che restringere gli spazi di rappresentanza popolare, dare potere ai grandi gruppi di capitale, restringere il dibattito pubblico: il taglio dei contributi all’editoria, ad esempio, ha fatto sparire la pluralità di voci della carta stampata che ancora sopravviveva dieci o quindici anni fa. L’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e la riduzione dei parlamentari rientrano in questo medesimo schema.Non posso sottoscrivere, invece, il giudizio liquidatorio sulle primarie, che possono avere molti difetti, ma di certo consentono di selezionare candidati popolari – parola tutt’altro che brutta, specie se la si legge come “in linea con lo spirito del tempo” – come avvenuto nel caso del PD, che nel giro di pochi anni ha eletto prima Renzi e poi Zingaretti grazie all’afflusso anche di elettori di forze rivali nel cui bacino poi il partito ha pescato. Difficilmente, credo, lezioni sull’organizzazione di un nuovo partito possono venire dai padri di una forza – Articolo Uno – che è stata fotografata dall’ultimo sondaggio (Euromedia su La Stampa del 5 agosto) allo 0,8%.
Alessandro Zabban
Il passaggio della Prima alla Seconda Repubblica è stato un passaggio da una Repubblica dei partiti a una dei leader. Erano in molti coloro che in Italia in quegli anni di passaggio si proclamavano ingenuamente seguaci del postmodernismo, banalizzandone la portata filosofica in una stereotipata “fine delle ideologie” e che plaudivano alla morte delle culture politiche e di quelle che venivano percepite come rigidità ideologiche. Questi personaggi sono spesso gli stessi che oggi si lamentano di una politica dominata dal carisma dei leader e che si stracciano le vesti di fronte a qualsiasi avvisaglia, vera o presunta, di populismo.In realtà il “crollo delle metanarrazioni”, tolto dall’ambito filosofico che gli compete, è diventato un utile strumento propagandistico per le forze conservatrici. La fine delle culture politiche è andato di pari passo con l’accettazione bipartisan della globalizzazione neoliberista, unica reale ideologia (il “capitalismo reale” di cui parla Mark Fisher), condivisa con varie sfumature da sinistra e da destra. L’opposizione a questo modello fatica enormemente a rialzare la testa, nonostante tutta una serie di crisi sistemiche o congiunturali che hanno di fatto disintegrato sogni e aspettative di una intera generazione, quella dei Millenials, e che minacciano ancor più il futuro dei nati dopo il 2000, nonché l’intero assetto delle società occidentali (senza parlare di come abbia aggravato la crisi ecologica).All’intero del modello che abbiamo dovuto subire per quasi 40 anni senza quasi nessuna forma tangibile di opposizione interna, la democrazia si è svuotata de suoi messaggi di uguaglianza sociale e di partecipazione collettiva per trasformarsi in uno show mediatico fra leader, tutti ideologicamente schierati con il modello produttivo vigente (ma che si possono presentare come non ideologici in un mondo in cui la loro ideologia è l’unica pensabile). La crescente accumulazione non solo di ricchezza ma anche di potere politico nelle mani della borghesia nazionale e delle elite liberiste transnazionali ha di fatto reso la democrazia un vuoto simulacro, in totale antitesi con i bisogni materiali e immateriali del popolo, utile solo come slogan quando è il momento di muovere lo scontro mediatico contro Cina, Venezuela o Corea del Nord. Il celebre saggio “Postdemocrazia” di Colin Crouch in tempi non sospetti metteva in guardia dalle dinamiche di declino delle istituzioni democratiche (e i movimenti neofascisti non ne sono la causa ma la conseguenza). Il 5 Stelle è stato un sintomo di questo malessere ma per cambiare realmente le cose si dovrà riprendere seriamente in mano Marx e probabilmente aspettare che gli equilibri geopolitici mondiali cambino.
Immagine da www.pixabay.com

Ogni martedì, dieci mani, di cinque autori de Il Becco, che partono da punti di vista diversi, attorno al “tema della settimana”. Una sorta di editoriale collettivo, dove non si ricerca la sintesi o lo scontro, ma un confronto (possibilmente interessante e utile).
A volta sono otto, altre dodici (le mani dietro agli articoli): ci teniamo elastici.